Ma
il santuario più frequentato da tutti i Tedeschi e che forma con tutti gli altri uno strano contrasto è quello della Consolatrix afflictorum di Kevelaer.
Si potrebbe chiamare "il proletario" tra i santuari e per il
 sito -
un'umile cittadina del Basso Reno di appena 20 mila abitanti e a circa 10 km
dalla frontiera olandese - e per l'immagine di Nostra Signora di Lussemburgo -
una semplice copia su carta delle dimensioni di cm 11x7,50. Questo
santuario fu richiesto dalla Vergine stessa, nel Natale del 1641, ad un
commerciante ambulante di nome Enrico Busman, che, passando nella campagna di
Kevelaer si era fermato a pregare in un crocevia davanti ad una edicola ed
aveva sentito una voce che gli ordinava: "In questo luogo devi
costruirmi
una piccola cappella". Sorpreso, il commerciante si guardò attorno e,
non avendo visto nessuno, proseguì la sua strada senza più preoccuparsi
dell'accaduto. Ma, una settimana più tardi, passando ancora di là, udì altre
volte le misteriose parole, il cui significato gli divenne chiaro e distinto,
allorché sua moglie, Matilde Schrouse, qualche mese dopo, ebbe una visione
notturna di una piccola cappella con dentro l'immagine della Madonna di
Lussemburgo, di cui ella aveva precedentemente rifiutato l'acquisto propostole
da due soldati di passaggio. I due coniugi si misero subito alla ricerca, ne
vennero in possesso, la incollarono su una tavoletta dipinta da loro stessi,
fecero costruire una piccola cappella e così il 1° giugno 1642 l'effigie della Vergine
consolatrice degli afflitti vi veniva solennemente collocata dal parroco di
Kevelaer. Quello stesso giorno una folla di fedeli di Geldern, capitale del
ducato di Guoldre, e delle località vicine accorsero alla cappella, dove si
verifìcarono diversi miracoli. Il
13 febbraio 1647, Enrico Busman, sotto giuramento, raccontò tutto ciò che gli
era accaduto cinque anni prima davanti ad una Commissione di 24 membri, riunita
a Venlo e composta di professori di teologia e di dottori in medicina. L'anno
stesso in cui fu posta nella piccola cappella la sacra immagine, si contarono
a volte fino a 20 mila pellegrini e, secondo una cronaca, negli anni
successivi ve ne giungevano più di 100 mila. Per accoglierli, tra il 1643 e il
1645, si costruì una chiesa e, nel 1647, la casa dei sacerdoti, destinata ad
ospitare gli Oratoriani invitati dal vescovo di Roermond per il servizio
spirituale dei pellegrini.
sito -
un'umile cittadina del Basso Reno di appena 20 mila abitanti e a circa 10 km
dalla frontiera olandese - e per l'immagine di Nostra Signora di Lussemburgo -
una semplice copia su carta delle dimensioni di cm 11x7,50. Questo
santuario fu richiesto dalla Vergine stessa, nel Natale del 1641, ad un
commerciante ambulante di nome Enrico Busman, che, passando nella campagna di
Kevelaer si era fermato a pregare in un crocevia davanti ad una edicola ed
aveva sentito una voce che gli ordinava: "In questo luogo devi
costruirmi
una piccola cappella". Sorpreso, il commerciante si guardò attorno e,
non avendo visto nessuno, proseguì la sua strada senza più preoccuparsi
dell'accaduto. Ma, una settimana più tardi, passando ancora di là, udì altre
volte le misteriose parole, il cui significato gli divenne chiaro e distinto,
allorché sua moglie, Matilde Schrouse, qualche mese dopo, ebbe una visione
notturna di una piccola cappella con dentro l'immagine della Madonna di
Lussemburgo, di cui ella aveva precedentemente rifiutato l'acquisto propostole
da due soldati di passaggio. I due coniugi si misero subito alla ricerca, ne
vennero in possesso, la incollarono su una tavoletta dipinta da loro stessi,
fecero costruire una piccola cappella e così il 1° giugno 1642 l'effigie della Vergine
consolatrice degli afflitti vi veniva solennemente collocata dal parroco di
Kevelaer. Quello stesso giorno una folla di fedeli di Geldern, capitale del
ducato di Guoldre, e delle località vicine accorsero alla cappella, dove si
verifìcarono diversi miracoli. Il
13 febbraio 1647, Enrico Busman, sotto giuramento, raccontò tutto ciò che gli
era accaduto cinque anni prima davanti ad una Commissione di 24 membri, riunita
a Venlo e composta di professori di teologia e di dottori in medicina. L'anno
stesso in cui fu posta nella piccola cappella la sacra immagine, si contarono
a volte fino a 20 mila pellegrini e, secondo una cronaca, negli anni
successivi ve ne giungevano più di 100 mila. Per accoglierli, tra il 1643 e il
1645, si costruì una chiesa e, nel 1647, la casa dei sacerdoti, destinata ad
ospitare gli Oratoriani invitati dal vescovo di Roermond per il servizio
spirituale dei pellegrini.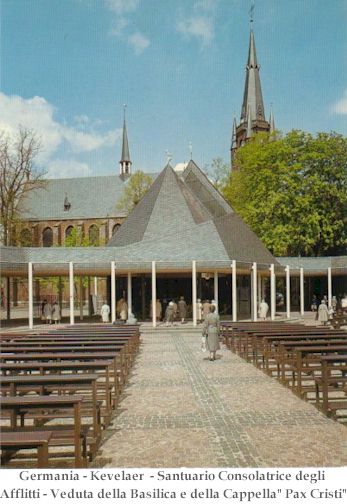 Poco
più tardi furono costruite la "Gnadenkapelle", la suggestiva
"Cappella delle Grazie" che si ammira ancor oggi al centro di una
magnifica piazza alberata e la "Kerzenkapelle", la
"Cappella dei ceri", così chiamata per i magnifici ceri che vi sono
custoditi e che ardono ogni giorno in lode e onore della Madonna. Dopo
il Congresso di Vienna e la pace ristabilita in Europa, l'afflusso dei
pellegrini divenne grandioso e sempre crescente fino ad arrivare a circa 400
mila all'anno, per cui si ritenne indispensabile la costruzione di una nuova
chiesa. Così nel 1858 si iniziò l'attuale basilica, che venne completata nel
1884 con un campanile alto 90 metri. Durante
la seconda guerra mondiale, nonostante che il santuario fosse situato in zona
di operazioni, si salvò per le preghiere alla Vergine degli abitanti del luogo
e per il coraggio di un ufficiale tedesco che non obbedì all'ordine di far
saltare la basilica e le cappelle delle Grazie e dei Ceri. Nel
dopoguerra i pellegrinaggi si moltiplicarono e nel 1948 vi si tenne il
Congresso di Pax-Christi, nel cui ricordo fu costruita la Pax-Christi-Kapelle,
che, inquadrata in un vasto cortile circondato da un porticato, si presta
ottimamente a celebrazioni comunitarie anche di grandi gruppi. Dal
1949 è accesa perpetuamente una lampada che simbolegga la preghiera incessante
di Kevelaer per la pace del mondo. La fiaccola viene da Lourdes,
passando per Altötting: così i tre santuari mariani sono riuniti per la
stessa supplica.
Poco
più tardi furono costruite la "Gnadenkapelle", la suggestiva
"Cappella delle Grazie" che si ammira ancor oggi al centro di una
magnifica piazza alberata e la "Kerzenkapelle", la
"Cappella dei ceri", così chiamata per i magnifici ceri che vi sono
custoditi e che ardono ogni giorno in lode e onore della Madonna. Dopo
il Congresso di Vienna e la pace ristabilita in Europa, l'afflusso dei
pellegrini divenne grandioso e sempre crescente fino ad arrivare a circa 400
mila all'anno, per cui si ritenne indispensabile la costruzione di una nuova
chiesa. Così nel 1858 si iniziò l'attuale basilica, che venne completata nel
1884 con un campanile alto 90 metri. Durante
la seconda guerra mondiale, nonostante che il santuario fosse situato in zona
di operazioni, si salvò per le preghiere alla Vergine degli abitanti del luogo
e per il coraggio di un ufficiale tedesco che non obbedì all'ordine di far
saltare la basilica e le cappelle delle Grazie e dei Ceri. Nel
dopoguerra i pellegrinaggi si moltiplicarono e nel 1948 vi si tenne il
Congresso di Pax-Christi, nel cui ricordo fu costruita la Pax-Christi-Kapelle,
che, inquadrata in un vasto cortile circondato da un porticato, si presta
ottimamente a celebrazioni comunitarie anche di grandi gruppi. Dal
1949 è accesa perpetuamente una lampada che simbolegga la preghiera incessante
di Kevelaer per la pace del mondo. La fiaccola viene da Lourdes,
passando per Altötting: così i tre santuari mariani sono riuniti per la
stessa supplica.
|
Papa
Giovanni Paolo II È
questa una nota rilevata anche da papa Giovanni Paolo II, che, nel suo viaggio
in Germania, il 2 maggio 1987, sostando a Kevelaer, rivolse un appassionato
discorso alla folla e disse tra le altre cose: "Insieme a me, vescovo di
Roma, vi sono qui credenti dei diversi Länden di Germania. Con noi sono
presenti credenti dei Paesi Bassi, del Belgio e del Lussemburgo, di Francia,
della Polonia e di molte altre nazioni. Quello che appare sogno e utopia agli
occhi di molti, è qui vero e reale: i confini scompaiono. Gli uomini si
riuniscono. L'estraneità si dissolve. Ciò che separa scompare. Perché la fede
comune degli uomini unisce. Perché ci conduce la comune speranza. Perché ci
anima l'amore comune. Qui esiste già l'Europa unita fatta di molti popoli,
quell'Europa che gli uomini politici cercano di formare attraverso difficoltà
innumerevoli. Qui è l'Europa della fede, che esisteva già nei secoli
passati". Nell'autunno
dello stesso anno ebbe luogo a Kevelaer anche il Congresso internazionale
mariologico (11-17 settembre) e mariano (17-20 settembre) con i temi: “Il culto
mariano nei secoli XIX e XX, fino al Concilio Vaticano II escluso";
"Maria, Madre dei credenti ". Kevelaer
ha una indiscutibile suggestività che attrae e commuove anche i cuori più
freddi e induriti nel male; anzi,
la caratteristica che lo distingue dagli altri santuari è unica più che rara:
non si va a Kevelaer per vedere dei miracoli, ma per riconciliarsi
con Dio tramite la sua buona Mamma e nelle ore del dolore ci si va a
sfogare con lei e a rinnovarle il proprio immutato affetto. In
questi ultimi anni, durante la stagione dei pellegrinaggi, che ufficialmente
va dal 1° maggio al 1° novembre, si registra una presenza di centinaia di
migliaia di pellegrini, provenienti soprattutto da ogni regione della
Germania e dai paesi del Benelux. Tralasciando di ricordare altri importanti
santuari, posso concludere che attualmente la devozione mariana in Germania è
molto intensa ed è frutto, oltre che di circostanze particolari, anche di
intellettuali convertiti in parte dal protestantesimo, che hanno ritrovato
l'ideale della Madre di Dio. Ogni
anno a Fulda, quando i vescovi cattolici di tutta la Germania si
riuniscono
per le loro conferenze episcopali sulla tomba di S. Bonifacio, non tralasciano
mai di salire sul Frauenberg (la Montagna della Vergine), per implorare
l'intercessione della Madonna lassù venerata e per organizzarvi suggestive
fiaccolate a chiusura dei loro convegni. |