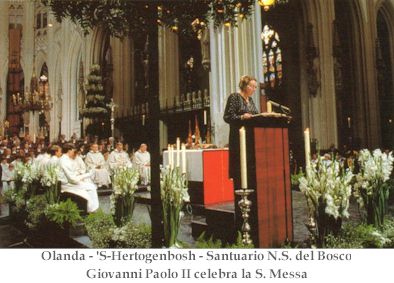La
storia dell'Olanda si confonde con quella del Belgio fino a quasi tutto il
1500; solo al termine di quel secolo le province settentrionali di quelle che
allora si chi amavano «Fiandre» si staccarono dalle province meridionali
(Belgio), dando origine a un nuovo Stato, dominato politicamente dal ceto
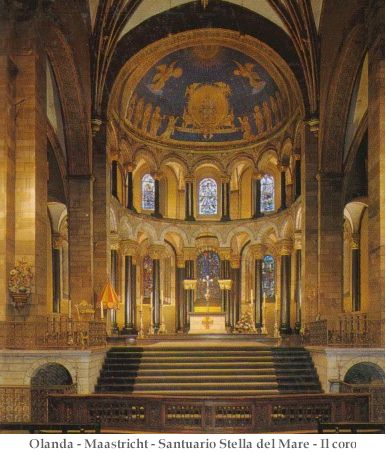 commerciale in forte espansione, e di religione calvinista.
commerciale in forte espansione, e di religione calvinista.
San
Servazio: il primo apostolo
Il
primo apostolo di quelle regioni fu san Servazio (384), che svolse il suo
ministero a Maastricht (nel sud, al confine con il Belgio): di lui si narra che
avesse costruito una cappella dedicata alla Vergine, da cui si sarebbe
sviluppato l'attuale santuario.
San
Wilfrido e san Willibrord
Nel
secolo VII, dopo le invasioni barbariche, il compito di rievangelizzare la
regione fu assunto dai monaci itineranti provenienti dall'Irlanda da poco
convertita. Fra di essi vanno ricordati
san Wilfrido e soprattutto san Willibrord (657-738), divenuto poi il santo più
popolare dei Paesi Bassi. Egli operò
soprattutto a Utrecht, dove fondò una chiesa mariana. Il cristianesimo si
diffuse ulteriormente nei secoli VIII e IX durante il dominio della dinastia
carolingia, e la Cappella Palatina della vicina Acquisgrana, divenne, grazie
alle sue molte reliquie, un'importante meta di pellegrinaggio.
Lo sviluppo del culto mariano
Dopo
il Mille, come in tutto il resto delle antiche Fiandre, si ebbe un grande
sviluppo del culto mariano, tanto che esso divenne uno degli elementi
caratteristici della società del tempo.
Il tema devozionale predominante fu quello della protezione, e si
assistette come ad una gara fra tutte le istituzioni della società dell'epoca:
nobili, corporazioni, confraternite, conventi, città... Ogni città aveva
un'immagine miracolosa della "Dolce Madre", che era quasi sempre una
statua di dimensioni ridotte e senza troppe pretese artistiche. Le mete di
pellegrinaggio più celebri si trovavano fuori dei confini dell'attuale Olanda,
come Acquisgrana e Einsiedeln (Svizzera); ce lo confermano le sentenze di alcuni
processi perché spesso i rei venivano condannati a compiere il pellegrinaggio
ad uno di questi luoghi.
La
fioritura nel campo dell’arte sacra
I secoli XIV e XV furono contraddistinti da
una notevole fioritura nel campo dell'arte sacra e l'atteggiamento spesso
ieratico delle immagini mariane si addolcì.
La nuova tendenza fu di rappresentarle in piedi, anziché in trono, con
un volto espressivo e non di rado sorridente.
Luci e ombre
Fu un periodo di profonda devozione ma anche
di grandi tensioni politiche e religiose: la contea d'Olanda, dopo varie
contese dinastiche, nel 1428 passò al duca di Borgogna e successivamente agli
Asburgo; molti furono gli attacchi al formalismo religioso sia nel suo aspetto
devozionale (con un'attenzione eccezionale rivolta a riti e cerimonie) sia
speculativo (la religione ridotta ad arido intellettualismo), e fra di esse fu
particolarmente significativo il contributo critico di Erasmo da Rotterdam
(1466-1536), che richiamava la pratica evangelica al suo aspetto essenziale: I"'imitazione
di Cristo". In questo clima di
irrequietezza spirituale i Paesi Bassi vennero lasciati in eredità da Carlo V
alla Spagna (1555) e la Riforma protestante assunse così le caratteristiche di
un movimento non solo religioso, ma anche politico, di indipendenza
nazionale. Le province del Nord
passarono praticamente in blocco al protestantesimo nella sua forma più
intransigente, rappresentata dal calvinismo, e resistettero validamente agli
eserciti spagnoli. Nel 1579 si
proclamarono indipendenti con l'Unione di Utrecht. I pochi cattolici rimasti in
tali regioni furono trattati come fuorilegge, privati dei diritti politici e
impediti ad esercitare pubblicamente il culto.
 Il trionfo della fede
Il trionfo della fede
Molte
statue furono date alle fiamme e le pitture delle chiese furono
cancellate. Qualche immagine, sottratta
per tempo alla distruzione, fu portata in salvo in Belgio. I santuari, come
ogni altro luogo di culto cattolico, furono aboliti nella loro totalità, e di
conseguenza anche le feste, i pellegrinaggi e le processioni. In alcuni luoghi le processioni e i
pellegrinaggi vennero preservati, ma camuffati sotto altre forme: è il caso di
's-Hertogenbosch, in cui l'antica processione che si faceva per sette sere
consecutive attorno alla città, divenne una composta e silenziosa passeggiata.
Molti olandesi andavano in pellegrinaggio ai santuari belgi, e in special modo
a quello di Montaigu. Ma il vero
santuario nazionale dei cattolici olandesi divenne quello di Kevelaer, sorto
nel corso del 1600 e situato in Germania vicino al confine con l'Olanda, in una
zona culturalmente affine. I
pellegrinaggi a questo santuario avvenivano senza apparire esternamente come
tali, quindi senza croci, stendardi o canti: ci si andava pregando in
silenzio. Gli ex voto e le targhe di
Kevelaer stanno ancora a testimoniare la devozione dei cattolici olandesi di
quei tempi.
Il
ritorno alla normalità
Nella
seconda metà del 1600, l'Olanda fu prima avversaria dell'Inghilterra, poi si
unì ad essa con l'elezione di Guglielmo III d'Orange al trono d'Inghilterra
(1688) e la nuova nemica divenne la Francia. Alla
fine del 1700 con l'occupazione napoleonica e la cacciata degli Orange, i
cattolici acquistarono gli stessi diritti degli altri olandesi e poterono
quindi ricominciare a professare pubblicamente, almeno in parte, la loro fede. Nel corso del 1800, soprattutto nel Sud, i
cattolici riottennero alcune delle loro antiche cattedrali e chiese, come
quelle di Maastricht e di 's-Hertogenbosch: risorsero così alcuni santuari
medioevali fra i quali quello di 's-Hertogenbosch, la cui statua, da anni in
esilio in Belgio, venne solennemente ricollocata al suo posto. I cattolici
olandesi furono fra i primi e i più assidui pellegrini di Lourdes e poi dei due
santuari belgi di Banneux e di Beauring.
La crisi del postconcilio
Nel corso del 1900, quando, dopo tre secoli di misure restrittive sulla libertà della fede cattolica, ogni problema sembrava definitivamente risolto, negli anni successivi al Concilio Vaticano II (1966-1979) si scatenò una nuova crisi mariana. Questa crisi mariana tra il clero, soprattutto giovane, non contagiò per fortuna la grande massa del buon popolo, che restò fedele alla pratica religiosa e alla devozione a Maria, continuando ad affluire ai santuari e ad ornarli di ceri, di fiori e di ex voto. Passata la bufera e tornata in sé la gente di Chiesa, negli anni Ottanta si è ripresa la recita pubblica del Rosario.