L'ARTE PER LA MADONNA DELLE GRAZIE DI PENNABILLI (di PierGiorgio Pasini)
Ogni possibile riflessione sull’immagine della Madonna delle Grazie venerata nella chiesa di San Cristoforo di Pennabilli deve tenere conto fin dall’inizio di due fatti. Un dato di stile: il dipinto ha tutti i caratteri del gotico internazionale come si è sviluppato nelle Marche settentrionali ad opera di artisti locali e non locali durante la prima metà del Quattrocento; e un dato documentario che permette di precisarne meglio la cronologia: l’altare ad essa relativo è stato consacrato il 16 novembre 1432 da Giovanni Secchiani (Seclani), vescovo del Montefeltro. La convergenza di questi due elementi ci permette di escludere che l’attuale immagine possa risalire al XIII secolo, come volevano gli storici di Pennabilli sulla scorta di una presunta iscrizione del 1222. Se pure è esistita, quell’antica Madonna è stata ‘rinnovata’, cioè completamente rifatta, per esigenze funzionali o devozionali, intorno al 1432.La Madonna delle Grazie di Pennabilli fa parte, e anzi faceva parte, di un complesso pittorico più vasto; si trovava al centro di tutta una parete figurata della quale è conservato un ampio frammento, solo ora veramente leggibile grazie al recente restauro. Per comprenderne il carattere occorre, naturalmente, tener conto di tutto l’insieme, che va immaginato in una chiesa o comunque in una cappella modesta, di forme gotiche, col pavimento più basso dell’attuale. Nell’ambiente originario le figurazioni, come stipate sulla parete, dovevano incombere con un effetto di solennità ben maggiore di quanto non appaia ora, ridotte come sono a frammenti in buona parte scorticati, disturbati da un insieme di elementi posteriori (peraltro preziosissimi) e diluite nello spazio vasto e un po’ informe dell’edificio odierno.Reintegrando idealmente la composizione si può almeno in parte ricuperarne il solenne effetto originario. Possiamo compiere questa operazione, sia pure con molti margini di incertezza, tenendo presente un’opera che ha molte affinità esterne con la nostra: la parete di fondo della Cella di Talamello, dipinta da Antonio Alberti e consacrata nel 1437. Sarà anzi importante sottolineare che essa è stata commissionata e consacrata da Giovanni Secchiani, lo stesso vescovo feretrano che nel 1432 aveva consacrato l’altare della Madonna di Pennabilli. Questo fatto, insieme alla sua prossimità cronologica e geografica (ed anche alla presumibile grandezza originaria), ne fa un ineludibile e prezioso elemento di confronto. In entrambe le opere le pareti sono divise orizzontalmente in due parti quasi uguali, in alto a contenere la scena dell’Annunciazione, in basso un Madonna col Bambino affiancata da Santi. In entrambe la testa nimbata della Madonna invade lo scomparto soprastante, quasi a voler unire le due parti, e soprattutto a voler accentuare la centralità ideale e materiale della figura di Maria, posta in primo piano come protagonista assoluta. Si noti tuttavia che la Madonna di Talamello è una «Madonna dell’umiltà», seduta in terra su un semplice cuscino e in vesti relativamente dimesse, secondo un’iconografia molto amata dai Francescani; non a caso il committente era il vescovo Secchiani, francescano appunto, che compariva a sinistra (e questa sua presenza va sottolineata anche per spiegare l’atteggiamento insolitamente vivace di Gesù); mentre quella di Pennabilli, commissionata dagli Agostiniani, è una «Madonna in maestà», cioè in trono come una regina. Nel dipinto di Pennabilli le figure vestono costumi ‘moderni’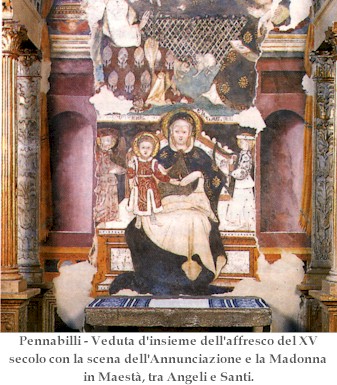 di singolare ricchezza, ricamati
d’oro e d’argento e tagliati in damaschi fioriti, e si dispongono rigidamente, o
solo di profilo o solo di fronte, secondo moduli arcaici appena attualizzati sui modelli
dei fastosi cerimoniali delle corti principesche: quindi gli angeli musici sono vestiti
come paggi, i santi di fianco al trono (purtroppo perduti) dovevano essere compunti
come cortigiani, mentre Gesù viene esibito come un principe dalla vestina foderata di
raso. Il risultato è una schematica scena di corte, insieme celeste e terrestre, in cui
si perde il senso drammatico del gesto di Maria che consegna al Figlio il cardellino,
simbolo della sua umanità e della sua passione futura. Anche per comprendere in pieno la
fastosità di queste immagini occorre fare un piccolo sforzo di immaginazione, inteso a
reintegrarle idealmente nei loro colori: la veste della Madonna era laminata
d’argento, come d’argento erano gli strumenti musicali degli angeli; il suo
mantello azzurro era foderato di bianco e trapunto da lettere auree che ne formavano il
nome, e inoltre decorato nei bordi da scritte gotiche dorate, ora solo parzialmente
leggibili. Una sontuosità straordinaria, dunque, che trova un parallelo, più che in
altri affreschi, soprattutto negli stupendi polittici veneziani importati in molti centri
marchigiani e romagnoli fra Tre e Quattrocento. Sulla Maestà è raffigurata l’Annunciazione,
quasi a sottolineare l’inizio dell’Incarnazione e della missione di Maria
come madre di Dio e dell’umanità redenta; l’attuale restauro ne ha permesso il
parziale recupero, ma sono perdute (e in parte nascoste) e le tradizionali quinte
architettoniche alle spalle delle figure, e la colomba dello Spirito Santo e il Padre
Eterno, che si affacciavano nel cerchio cosmico sovrastante, a dominare tutto
l’affresco e tutto l’ambiente. Anche questa scena, svolta secondo ritmi e
cadenze che privilegiano linee fluenti e piatte composizioni cromatiche, ha un tono
cortese, accentuato dalle stoffe preziose i cui ricami d’argento non si piegano e non
scorciano, dal recinto di canne fiorito di rose, dal vivace scontro del cane e del gatto;
simboli molto usati in questo periodo, ma chissà quanto ancora capaci di comunicare
qualcosa ai fedeli, che probabilmente già li consideravano, come noi, soprattutto
piacevoli elementi naturalistici. L’analogia dell’insieme compositivo negli
affreschi di Pennabilli e di Talamello è troppo stringente per essere casuale. Ma nelle
sue linee programmatiche essa va imputata, più che ai pittori, ai committenti, che
evidentemente si servivano delle stesse fonti o accoglievano gli stessi suggerimenti:
potrebbe essere stato il vescovo Secchiani a dettare i temi di entrambe le opere.
L’analogia, comunque, non si ferma all’impianto: anche i dati di stile offrono
qualche corrispondenza. Ma qui a Pennabilli si avvertono più forti le suggestioni
settentrionali, cioè lombarde e venete, un colore più smaltato e forme più massicce, e
soprattutto un certo impaccio, forse accentuato dallo sfarzo decorativo così
insistentemente ricercato; si riscontrano anche contrasti fra l’impianto compositivo,
volutamente solenne e monumentale fino a divenire arcaico, ed una realizzazione in alcuni
tratti, e specialmente nei particolari, affaticata e incerta. Si noti per esempio
l’ampio svolgersi del manto della Vergine, così naturale e solenne in contrasto con
il profilo piatto degli angeli musicanti e l’affaticato scorciare delle loro mani.
Anche la frontalità assoluta della Madonna e di Gesù risulta piuttosto arcaica:
certo non fu mai particolarmente evitata dai pittori tardo gotici marchigiani, e fra gli
altri l’Alberti in più di un caso se ne è compiaciuto, ma qui appare
eccessiva nella sua staticità. I contatti con l’Alberti non mancano, anzi sono
numerosi; sembra trattarsi però di analogie di gusto e anche di influenze dirette, non di
identità di mano. L’autore andrà ricercato fra i numerosi artisti attivi in questo
periodo nelle Marche, ancora poco conosciuti o affatto sconosciuti. Potrebbe trattarsi per
esempio del padre di Giovanni Antonio da Pesaro, recentemente ‘risuscitato’
dalle ricerche di Paride Bernardi: cioè di Gigliolo Bellinzoni da Parma, di cui non
conosciamo nulla, ma fin dal secondo decennio del secolo molto attivo a Pesaro e per i
Malatesti. L’educazione padana, l’area di attività, le relazioni di lavoro, i
committenti di questo artista potrebbero rendere suggestiva l’ipotesi di una sua
attività pennese, eventualmente in collaborazione con la bottega dell’Alberti; ma
sia ben chiaro che questa è appena un’incerta e anzi fantasiosa ipotesi, che si può
avanzare solo per alcune labili analogie con lo stile del figlio. Dunque gli unici
elementi che mi sembra si possano dare per certi sono l’appartenenza dell’opera
agli anni trenta del Quattrocento e a quel circuito di cultura tardo gotica padana o
comunque influenzata dalla padània che investì fortemente le Marche settentrionali ed
ebbe fra il Marecchia e il Metauro larga ospitalità, conservandosi vitale e influenzando
per alcuni decenni lo sviluppo della cultura locale, confortata dall’arrivo di
prodotti «di lusso» soprattutto lombardi e veneti. Anche i costumi così elaborati degli
angeli e del Bambino mi sembra rientrino nella tradizione cortese di quella cultura e
rimandino a mode settentrionali presto generalmente diffuse: basterà confrontarli per
esempio con alcune figure di Gentile da Fabriano o di Masolino, contemporanee alle nostre,
per rendercene persuasi. Per quanto riguarda l’abito di Gesù, sembra proprio la
veste cerimoniale di un principe; ma sarà appena il caso di ricordare che, sia pure in
fogge diverse, vesti cerimoniali lussuose e ricercate sono indossate da molti Gesù
marchigiani (da quelli di Allegretto Nuzi e di Gentile da Fabriano a quelli di Arcangelo
di Cola). Ora la parte inferiore e centrale del nostro affresco appare particolarmente
consunta: cioè lo specchio del trono, che era decorato con piccole geometrie cosmatesche
di gusto trecentesco, le parti inferiori delle vesti degli angeli, i piedi del Bambino e
soprattutto il manto della Vergine, che ha perduto gran parte dell’azzurro
sovrapposto al tradizionale «morellone» di fondo e quasi tutte le decorazioni auree, ed
inoltre il colore della sua fodera bianca. Il motivo può essere ricercato in una serie di
‘devote’ manutenzioni consistenti in ripetuti lavaggi intesi a ripulire la
superficie dal fumo delle candele e delle torce; questi lavaggi hanno a poco a poco fatto
scomparire i colori più delicati, le rifiniture eseguite in oro e a tempera, e
specialmente la biacca con cui era modellato tutto il rovescio del manto.
di singolare ricchezza, ricamati
d’oro e d’argento e tagliati in damaschi fioriti, e si dispongono rigidamente, o
solo di profilo o solo di fronte, secondo moduli arcaici appena attualizzati sui modelli
dei fastosi cerimoniali delle corti principesche: quindi gli angeli musici sono vestiti
come paggi, i santi di fianco al trono (purtroppo perduti) dovevano essere compunti
come cortigiani, mentre Gesù viene esibito come un principe dalla vestina foderata di
raso. Il risultato è una schematica scena di corte, insieme celeste e terrestre, in cui
si perde il senso drammatico del gesto di Maria che consegna al Figlio il cardellino,
simbolo della sua umanità e della sua passione futura. Anche per comprendere in pieno la
fastosità di queste immagini occorre fare un piccolo sforzo di immaginazione, inteso a
reintegrarle idealmente nei loro colori: la veste della Madonna era laminata
d’argento, come d’argento erano gli strumenti musicali degli angeli; il suo
mantello azzurro era foderato di bianco e trapunto da lettere auree che ne formavano il
nome, e inoltre decorato nei bordi da scritte gotiche dorate, ora solo parzialmente
leggibili. Una sontuosità straordinaria, dunque, che trova un parallelo, più che in
altri affreschi, soprattutto negli stupendi polittici veneziani importati in molti centri
marchigiani e romagnoli fra Tre e Quattrocento. Sulla Maestà è raffigurata l’Annunciazione,
quasi a sottolineare l’inizio dell’Incarnazione e della missione di Maria
come madre di Dio e dell’umanità redenta; l’attuale restauro ne ha permesso il
parziale recupero, ma sono perdute (e in parte nascoste) e le tradizionali quinte
architettoniche alle spalle delle figure, e la colomba dello Spirito Santo e il Padre
Eterno, che si affacciavano nel cerchio cosmico sovrastante, a dominare tutto
l’affresco e tutto l’ambiente. Anche questa scena, svolta secondo ritmi e
cadenze che privilegiano linee fluenti e piatte composizioni cromatiche, ha un tono
cortese, accentuato dalle stoffe preziose i cui ricami d’argento non si piegano e non
scorciano, dal recinto di canne fiorito di rose, dal vivace scontro del cane e del gatto;
simboli molto usati in questo periodo, ma chissà quanto ancora capaci di comunicare
qualcosa ai fedeli, che probabilmente già li consideravano, come noi, soprattutto
piacevoli elementi naturalistici. L’analogia dell’insieme compositivo negli
affreschi di Pennabilli e di Talamello è troppo stringente per essere casuale. Ma nelle
sue linee programmatiche essa va imputata, più che ai pittori, ai committenti, che
evidentemente si servivano delle stesse fonti o accoglievano gli stessi suggerimenti:
potrebbe essere stato il vescovo Secchiani a dettare i temi di entrambe le opere.
L’analogia, comunque, non si ferma all’impianto: anche i dati di stile offrono
qualche corrispondenza. Ma qui a Pennabilli si avvertono più forti le suggestioni
settentrionali, cioè lombarde e venete, un colore più smaltato e forme più massicce, e
soprattutto un certo impaccio, forse accentuato dallo sfarzo decorativo così
insistentemente ricercato; si riscontrano anche contrasti fra l’impianto compositivo,
volutamente solenne e monumentale fino a divenire arcaico, ed una realizzazione in alcuni
tratti, e specialmente nei particolari, affaticata e incerta. Si noti per esempio
l’ampio svolgersi del manto della Vergine, così naturale e solenne in contrasto con
il profilo piatto degli angeli musicanti e l’affaticato scorciare delle loro mani.
Anche la frontalità assoluta della Madonna e di Gesù risulta piuttosto arcaica:
certo non fu mai particolarmente evitata dai pittori tardo gotici marchigiani, e fra gli
altri l’Alberti in più di un caso se ne è compiaciuto, ma qui appare
eccessiva nella sua staticità. I contatti con l’Alberti non mancano, anzi sono
numerosi; sembra trattarsi però di analogie di gusto e anche di influenze dirette, non di
identità di mano. L’autore andrà ricercato fra i numerosi artisti attivi in questo
periodo nelle Marche, ancora poco conosciuti o affatto sconosciuti. Potrebbe trattarsi per
esempio del padre di Giovanni Antonio da Pesaro, recentemente ‘risuscitato’
dalle ricerche di Paride Bernardi: cioè di Gigliolo Bellinzoni da Parma, di cui non
conosciamo nulla, ma fin dal secondo decennio del secolo molto attivo a Pesaro e per i
Malatesti. L’educazione padana, l’area di attività, le relazioni di lavoro, i
committenti di questo artista potrebbero rendere suggestiva l’ipotesi di una sua
attività pennese, eventualmente in collaborazione con la bottega dell’Alberti; ma
sia ben chiaro che questa è appena un’incerta e anzi fantasiosa ipotesi, che si può
avanzare solo per alcune labili analogie con lo stile del figlio. Dunque gli unici
elementi che mi sembra si possano dare per certi sono l’appartenenza dell’opera
agli anni trenta del Quattrocento e a quel circuito di cultura tardo gotica padana o
comunque influenzata dalla padània che investì fortemente le Marche settentrionali ed
ebbe fra il Marecchia e il Metauro larga ospitalità, conservandosi vitale e influenzando
per alcuni decenni lo sviluppo della cultura locale, confortata dall’arrivo di
prodotti «di lusso» soprattutto lombardi e veneti. Anche i costumi così elaborati degli
angeli e del Bambino mi sembra rientrino nella tradizione cortese di quella cultura e
rimandino a mode settentrionali presto generalmente diffuse: basterà confrontarli per
esempio con alcune figure di Gentile da Fabriano o di Masolino, contemporanee alle nostre,
per rendercene persuasi. Per quanto riguarda l’abito di Gesù, sembra proprio la
veste cerimoniale di un principe; ma sarà appena il caso di ricordare che, sia pure in
fogge diverse, vesti cerimoniali lussuose e ricercate sono indossate da molti Gesù
marchigiani (da quelli di Allegretto Nuzi e di Gentile da Fabriano a quelli di Arcangelo
di Cola). Ora la parte inferiore e centrale del nostro affresco appare particolarmente
consunta: cioè lo specchio del trono, che era decorato con piccole geometrie cosmatesche
di gusto trecentesco, le parti inferiori delle vesti degli angeli, i piedi del Bambino e
soprattutto il manto della Vergine, che ha perduto gran parte dell’azzurro
sovrapposto al tradizionale «morellone» di fondo e quasi tutte le decorazioni auree, ed
inoltre il colore della sua fodera bianca. Il motivo può essere ricercato in una serie di
‘devote’ manutenzioni consistenti in ripetuti lavaggi intesi a ripulire la
superficie dal fumo delle candele e delle torce; questi lavaggi hanno a poco a poco fatto
scomparire i colori più delicati, le rifiniture eseguite in oro e a tempera, e
specialmente la biacca con cui era modellato tutto il rovescio del manto. Oltre ad
essere pulita l’immagine deve essere stata di tanto in tanto
‘rinfrescata’, o ritoccata: uno di questi interventi è ricordato come eseguito
a spese della comunità nel 1475 da Pier Giovanni da Piandimeleto, fratello del più noto,
ma egualmente sconosciuto, Evangelista: forse rinfrescò le dorature o ne applicò di
nuove, e ridipinse a secco alcune parti consunte o cadute, ma non credo modificasse
sostanzialmente il dipinto, il cui assetto invece subì un profondo cambiamento dopo i
miracoli del 1517 e 1522. Infatti subito dopo l’ultimo miracolo la chiesa di San
Cristoforo, divenuta angusta per l’accresciuto concorso dei fedeli, venne rifatta
più grande. Della chiesa originaria solo la parte di muro con la prodigiosa
raffigurazione venne salvata; ma essa aveva bisogno di essere rafforzata dal punto di
vista statico, mentre il dipinto aveva bisogno di una adeguata velarizzazione
architettonica. Il problema fu risolto includendo muro ed immagine in una splendida
edicola di forme moderne, cioè pienamente rinascimentali, che permetteva di accentrare
l’attenzione unicamente sulla Madonna col Bambino. Due iscrizioni, nel fregio
e sul lato sinistro, ci permettono di datarne la costruzione al 1528. Per quanto
riguarda la tipologia del nuovo monumento, essa è ricca di suggestivi rimandi, dalle pergulae
e dagli archi trionfali pagani, fino ai cibori e ai baldacchini degli antichi altari
cristiani. Ma va sottolineato che fra Quattro e Cinquecento sono numerose le cappelle,
anzi i tabernacoli mariani di questo tipo costruiti all’interno di edifici sacri. Ne
ricordo solo due, abbastanza vicini dal punto di vista cronologico, geografico e
stilistico, oltre che tipologico: quello della Madonna del Piratello di Imola, databile
all’inizio del Cinquecento, che offre elementi toscani (in esecuzione lombarda)
desunti in buona parte dal tabernacolo fiorentino di San Miniato al Monte, attribuito a
Michelozzo; e l’altare della Madonna di Pianetto di Galeata, del 1534, e perciò
quasi contemporaneo al nostro, realizzato in forme più popolaresche, ma di simili
proporzioni e dalla identica collocazione all’interno della chiesa, che credo dovuta
a necessità o preferenze liturgiche. In questa serie potrebbero essere richiamati per le
loro analogie formali molti altri sacelli, dall’altare di Santa Maria Maggiore a
Spello (eseguito da Rocco da Vicenza nel 1515), a quello della Madonna del Calcinaio
presso Cortona (eseguito da Andrea Sansovino e Bernardino Covatti nel 1519); ma è inutile
allungare l’elenco dei possibili riferimenti, che potrebbero invece includere
un’altra ‘classe’ di monumenti (e forse dovrebbero, dato che la Madonna
viene invocata anche come Janua Coeli): cioè i protiri che impreziosivano le
facciate e proteggevano le porte delle chiese rinascimentali, tanto numerosi nelle Marche.
E non potrà sfuggire la somiglianza in particolare con quello di San Domenico di Urbino,
che, pur vecchio di molti decenni, costituiva ancora un prototipo ammirato e imitato. Ma
dal punto di vista architettonico e decorativo un rimando generico all’arte urbinate
nel suo insieme sembra sufficiente e pertinente, e così evidente che non avrebbe molto
senso insistervi. Solo occorrerà forse precisare: a quella dei sempre attivi
cantieri ducali nei decenni fra Quattro e Cinquecento, ornata da fregi di lapicidi
lombardi, da elementi epigrafici di straordinaria raffinatezza e modellata su un dolce,
aureo eclettismo. All’ambiente della corte ducale ci riporta anche la nuova
decorazione pittorica; anzi, nel suo scompartirsi armonioso, nel suo attento incastro
geometrico di finte profilature marmoree, nel suo illusionistico aprirsi di cortine, di
oculi, di nicchie rosate, nei colti richiami all’antichità e infine nel dolce
classicismo delle figurazioni, richiama con precisione l’attività delle maestranze
impegnate all’Imperiale di Pesaro su commissione di Francesco Maria della Rovere e di
Eleonora Gonzaga. In particolare vi si avvertono suggestioni raffaellesche che fanno
pensare a Raffaellino del Colle, specialmente per l’Annunciazione del fianco,
dai colori teneri, dal disegno nitido e dall’esecuzione fine e sorvegliata. Ma
forse l’autore andrà cercato fra collaboratori minori, dato che
l’esecuzione delle altre parti non sembra all’altezza
dell’ideazione raffinatissima. Si noti che anche nel nuovo assetto decorativo si
cercò di non tradire o diminuire i significati della composizione originaria: la figura
del Padre Eterno fu dipinta nella lunetta a dominare l’insieme, sovrastata dalla
Colomba dello Spirito Santo al centro dell’imbotte; e l’Annunciazione venne
dipinta sul fianco esterno meglio visibile del nuovo tabernacolo. La composizione anzi fu
arricchita di significati: infatti nell’imbotte sono stati inseriti i volti dei
progenitori, a significare l’inizio dell’umanità, il peccato originale e
l’attesa della Redenzione, che ha il suo prologo nell’Annunciazione e la sua
attuazione nell’Incarnazione. Le figure protagoniste dell’altare, cioè
la Madonna e il Bambino, dovevano essere racchiuse da una grande cornice lignea di cui si
può ricuperare il profilo esterno seguendo i limiti dell’affresco cinquecentesco, e
di cui si può immaginare la parte superiore rettilinea, idealmente ricostruibile sulla
base delle cornici dipinte lateralmente. Non si trattava certamente di un elemento
superfluo o secondario, ma necessario ad isolare l’immagine miracolosa e ad
articolare maggiormente dal punto di vista formale la composizione, modesta e tuttavia
notevolmente complessa nelle sue scenografiche, illusionistiche stratificazioni, per le
quali forse non sarebbe inutile evocare il nome di Girolamo Genga. L’iscrizione
principale sulla fronte del monumento attribuisce classicamente la decisione di erigere il
sacello al «Senato e Popolo Pennese», e quella sul fianco cita i priori e i sindaci
della confraternita. Che l’opera sia stata promossa ed accuratamente
progettata in loco è dimostrato dalla cura con cui si cercarono di recuperare tutti i
temi del vecchio affresco e dalla pretenziosità classicistica delle iscrizioni scolpite e
dipinte, di disegno raffinato quanto di costruzione approssimativa ed oscura. Tuttavia
credo che la corte urbinate - fra l’altro anch’essa beneficiata dai miracoli
‘antimedicei’ della Madonna di Pennabilli - non abbia fatto mancare il suo
appoggio, il suo consiglio ed il suo contributo all’opera: e gli scacchi neri e
dorati nei pennacchi dell’arco esterno sembrano alludere discretamente
all’autorevole presenza dei duchi. Ma a renderci sicuri di questa partecipazione è
lo stile stesso dell’opera, che in un certo senso costituisce un’anomalia nella
tradizione pennese. Non dimentichiamo infatti che fino a quel momento le opere pittoriche
di maggior peso erano state commissionate a Bimini, alla bottega dei Coda, che pochi anni
prima, nel 1520, aveva inviato a Pennabilli un bel polittico ed a Torricella un trittico
a sportelli mobili, firmati da Benedetto Coda; anche se modeste dal punto di vista
artistico, entrambi erano opere importanti e comunque ufficiali, perché si fregiavano
degli stemmi delle due comunità. Nell’intervento dei duchi – comunque si fosse
conformato – si deve vedere, oltre che un atto di devozione e di gratitudine verso la
Madonna, un preciso atto politico, ed anzi di politica culturale, inteso ad allargare
l’immagine, l’influenza e quindi la presenza del governo nel territorio anche
attraverso un gusto particolare, alimentato da artisti di corte. Non è un caso, forse,
che pochi anni dopo un altro pittore dell’Imperiale, Francesco Menzocchi, fosse
mandato a dipingere un polittico importante in un territorio confinante ed alleato, cioè
a San Marino, a gara ancora una volta con la bottega dei Coda, artisti di altro territorio
e di altra cultura. D’altra parte l’altare della Madonna delle Grazie non
costituisce un fatto isolato dal punto di vista stilistico, perché nella zona esistono
parecchie altre opere dello stesso periodo riecheggianti il Rinascimento urbinate: per
esempio il presbiterio, costruito o sistemato nel primo decennio del secolo, di Santa
Maria d’Antico; Santa Maria dell’Oliva a Maciano, con il portale datato al 1529
ed elementi architettonici e decorativi in pietra, all’interno, del 1569; in paese la
chiesa dell’ospedale della Misericordia, di cui è superstite la bellissima lunetta
in pietra, sul portale, anch’essa di gusto urbinate. Dell’assetto di altre
costruzioni di questi anni, nuove come il monastero di Sant’Antonio della Penna, o
rinnovate, non sappiamo praticamente nulla, a cominciare dalla stessa chiesa di San
Cristoforo in cui si trova la nostra Madonna. Con questo vorrei sottolineare che
l’impresa della nuova edicola, pur eccezionale per quanto riguarda il livello,
partecipa ad un clima culturale particolare, che definirei ufficiale, che si cercava di
radicare nella zona grazie a interventi diretti della corte (o di cortigiani: gli Oliva,
nel nostro caso), o indiretti, cioè con consigli, suggerimenti, consulenze di artisti e
artigiani ducali. Sembra, però, che localmente non ci si sia mai sentiti troppo legati da
questi dettami di politica artistica. Un esempio di tale indipendenza può essere
segnalato fin dal 1533, quando per la commissione di una tavola raffigurante San Sireno
(un santo collegato dai pennesi proprio al culto della Madonna delle Grazie) ci si
rivolse, seguendo una vecchia consuetudine, alla solita bottega riminese dei Coda.
Naturalmente non sappiamo dire se si trattò di una scelta polemica o semplicemente di uno
dei tanti sintomi della gravitazione naturale di Pennabilli verso la bassa valle del
Marecchia. Certo anche in seguito, nel corso del XVI e XVII secolo, vi troviamo opere
d’arte provenienti dalla Romagna, dall’Umbria e dalla Toscana: ma soprattutto vi
troviamo opere marchigiane. Marchigiano, anche se con notevoli influenze emiliano
romagnole, sembra il diligente pittore che intorno alla metà del XVI secolo ha dipinto la
pala della Resurrezione in questa stessa chiesa di San Cristoforo, da tenere
particolarmente presente perché alcuni dei santi che vi sono raffigurati potevano essere
quelli originariamente dipinti accanto alla Madonna delle Grazie, cancellati nel 1528
durante la costruzione dell’edicola. E perché appartiene alla stessa corrente
dell’artista che ha affrescato le scene eucaristiche di fianco al nuovo
tabernacolo della Madonna, scoperte con la recente rimozione delle parti lignee e con
l’attuale restauro, ma che non hanno niente a che fare con esso né dal punto di
vista concettuale, né da quello formale. Il Marchigiano è anche il pittore che ha
dipinto, sempre per questa chiesa, una splendida e sciupata Adorazione dei Magi che
si dimostra ricca di elementi di cultura simili a quelli del pittore dell’edicola
della Madonna, per quanto maturati dal tempo e da contatti nordici: sembra molto vicino al
fanese Giuliano Presutti nella sua attività tarda: la sua Sant’Orsola di
Ancona del 1554, infatti, si confronta abbastanza bene col nostro dipinto, che dovrebbe
risalire alla metà del secolo.
Oltre ad
essere pulita l’immagine deve essere stata di tanto in tanto
‘rinfrescata’, o ritoccata: uno di questi interventi è ricordato come eseguito
a spese della comunità nel 1475 da Pier Giovanni da Piandimeleto, fratello del più noto,
ma egualmente sconosciuto, Evangelista: forse rinfrescò le dorature o ne applicò di
nuove, e ridipinse a secco alcune parti consunte o cadute, ma non credo modificasse
sostanzialmente il dipinto, il cui assetto invece subì un profondo cambiamento dopo i
miracoli del 1517 e 1522. Infatti subito dopo l’ultimo miracolo la chiesa di San
Cristoforo, divenuta angusta per l’accresciuto concorso dei fedeli, venne rifatta
più grande. Della chiesa originaria solo la parte di muro con la prodigiosa
raffigurazione venne salvata; ma essa aveva bisogno di essere rafforzata dal punto di
vista statico, mentre il dipinto aveva bisogno di una adeguata velarizzazione
architettonica. Il problema fu risolto includendo muro ed immagine in una splendida
edicola di forme moderne, cioè pienamente rinascimentali, che permetteva di accentrare
l’attenzione unicamente sulla Madonna col Bambino. Due iscrizioni, nel fregio
e sul lato sinistro, ci permettono di datarne la costruzione al 1528. Per quanto
riguarda la tipologia del nuovo monumento, essa è ricca di suggestivi rimandi, dalle pergulae
e dagli archi trionfali pagani, fino ai cibori e ai baldacchini degli antichi altari
cristiani. Ma va sottolineato che fra Quattro e Cinquecento sono numerose le cappelle,
anzi i tabernacoli mariani di questo tipo costruiti all’interno di edifici sacri. Ne
ricordo solo due, abbastanza vicini dal punto di vista cronologico, geografico e
stilistico, oltre che tipologico: quello della Madonna del Piratello di Imola, databile
all’inizio del Cinquecento, che offre elementi toscani (in esecuzione lombarda)
desunti in buona parte dal tabernacolo fiorentino di San Miniato al Monte, attribuito a
Michelozzo; e l’altare della Madonna di Pianetto di Galeata, del 1534, e perciò
quasi contemporaneo al nostro, realizzato in forme più popolaresche, ma di simili
proporzioni e dalla identica collocazione all’interno della chiesa, che credo dovuta
a necessità o preferenze liturgiche. In questa serie potrebbero essere richiamati per le
loro analogie formali molti altri sacelli, dall’altare di Santa Maria Maggiore a
Spello (eseguito da Rocco da Vicenza nel 1515), a quello della Madonna del Calcinaio
presso Cortona (eseguito da Andrea Sansovino e Bernardino Covatti nel 1519); ma è inutile
allungare l’elenco dei possibili riferimenti, che potrebbero invece includere
un’altra ‘classe’ di monumenti (e forse dovrebbero, dato che la Madonna
viene invocata anche come Janua Coeli): cioè i protiri che impreziosivano le
facciate e proteggevano le porte delle chiese rinascimentali, tanto numerosi nelle Marche.
E non potrà sfuggire la somiglianza in particolare con quello di San Domenico di Urbino,
che, pur vecchio di molti decenni, costituiva ancora un prototipo ammirato e imitato. Ma
dal punto di vista architettonico e decorativo un rimando generico all’arte urbinate
nel suo insieme sembra sufficiente e pertinente, e così evidente che non avrebbe molto
senso insistervi. Solo occorrerà forse precisare: a quella dei sempre attivi
cantieri ducali nei decenni fra Quattro e Cinquecento, ornata da fregi di lapicidi
lombardi, da elementi epigrafici di straordinaria raffinatezza e modellata su un dolce,
aureo eclettismo. All’ambiente della corte ducale ci riporta anche la nuova
decorazione pittorica; anzi, nel suo scompartirsi armonioso, nel suo attento incastro
geometrico di finte profilature marmoree, nel suo illusionistico aprirsi di cortine, di
oculi, di nicchie rosate, nei colti richiami all’antichità e infine nel dolce
classicismo delle figurazioni, richiama con precisione l’attività delle maestranze
impegnate all’Imperiale di Pesaro su commissione di Francesco Maria della Rovere e di
Eleonora Gonzaga. In particolare vi si avvertono suggestioni raffaellesche che fanno
pensare a Raffaellino del Colle, specialmente per l’Annunciazione del fianco,
dai colori teneri, dal disegno nitido e dall’esecuzione fine e sorvegliata. Ma
forse l’autore andrà cercato fra collaboratori minori, dato che
l’esecuzione delle altre parti non sembra all’altezza
dell’ideazione raffinatissima. Si noti che anche nel nuovo assetto decorativo si
cercò di non tradire o diminuire i significati della composizione originaria: la figura
del Padre Eterno fu dipinta nella lunetta a dominare l’insieme, sovrastata dalla
Colomba dello Spirito Santo al centro dell’imbotte; e l’Annunciazione venne
dipinta sul fianco esterno meglio visibile del nuovo tabernacolo. La composizione anzi fu
arricchita di significati: infatti nell’imbotte sono stati inseriti i volti dei
progenitori, a significare l’inizio dell’umanità, il peccato originale e
l’attesa della Redenzione, che ha il suo prologo nell’Annunciazione e la sua
attuazione nell’Incarnazione. Le figure protagoniste dell’altare, cioè
la Madonna e il Bambino, dovevano essere racchiuse da una grande cornice lignea di cui si
può ricuperare il profilo esterno seguendo i limiti dell’affresco cinquecentesco, e
di cui si può immaginare la parte superiore rettilinea, idealmente ricostruibile sulla
base delle cornici dipinte lateralmente. Non si trattava certamente di un elemento
superfluo o secondario, ma necessario ad isolare l’immagine miracolosa e ad
articolare maggiormente dal punto di vista formale la composizione, modesta e tuttavia
notevolmente complessa nelle sue scenografiche, illusionistiche stratificazioni, per le
quali forse non sarebbe inutile evocare il nome di Girolamo Genga. L’iscrizione
principale sulla fronte del monumento attribuisce classicamente la decisione di erigere il
sacello al «Senato e Popolo Pennese», e quella sul fianco cita i priori e i sindaci
della confraternita. Che l’opera sia stata promossa ed accuratamente
progettata in loco è dimostrato dalla cura con cui si cercarono di recuperare tutti i
temi del vecchio affresco e dalla pretenziosità classicistica delle iscrizioni scolpite e
dipinte, di disegno raffinato quanto di costruzione approssimativa ed oscura. Tuttavia
credo che la corte urbinate - fra l’altro anch’essa beneficiata dai miracoli
‘antimedicei’ della Madonna di Pennabilli - non abbia fatto mancare il suo
appoggio, il suo consiglio ed il suo contributo all’opera: e gli scacchi neri e
dorati nei pennacchi dell’arco esterno sembrano alludere discretamente
all’autorevole presenza dei duchi. Ma a renderci sicuri di questa partecipazione è
lo stile stesso dell’opera, che in un certo senso costituisce un’anomalia nella
tradizione pennese. Non dimentichiamo infatti che fino a quel momento le opere pittoriche
di maggior peso erano state commissionate a Bimini, alla bottega dei Coda, che pochi anni
prima, nel 1520, aveva inviato a Pennabilli un bel polittico ed a Torricella un trittico
a sportelli mobili, firmati da Benedetto Coda; anche se modeste dal punto di vista
artistico, entrambi erano opere importanti e comunque ufficiali, perché si fregiavano
degli stemmi delle due comunità. Nell’intervento dei duchi – comunque si fosse
conformato – si deve vedere, oltre che un atto di devozione e di gratitudine verso la
Madonna, un preciso atto politico, ed anzi di politica culturale, inteso ad allargare
l’immagine, l’influenza e quindi la presenza del governo nel territorio anche
attraverso un gusto particolare, alimentato da artisti di corte. Non è un caso, forse,
che pochi anni dopo un altro pittore dell’Imperiale, Francesco Menzocchi, fosse
mandato a dipingere un polittico importante in un territorio confinante ed alleato, cioè
a San Marino, a gara ancora una volta con la bottega dei Coda, artisti di altro territorio
e di altra cultura. D’altra parte l’altare della Madonna delle Grazie non
costituisce un fatto isolato dal punto di vista stilistico, perché nella zona esistono
parecchie altre opere dello stesso periodo riecheggianti il Rinascimento urbinate: per
esempio il presbiterio, costruito o sistemato nel primo decennio del secolo, di Santa
Maria d’Antico; Santa Maria dell’Oliva a Maciano, con il portale datato al 1529
ed elementi architettonici e decorativi in pietra, all’interno, del 1569; in paese la
chiesa dell’ospedale della Misericordia, di cui è superstite la bellissima lunetta
in pietra, sul portale, anch’essa di gusto urbinate. Dell’assetto di altre
costruzioni di questi anni, nuove come il monastero di Sant’Antonio della Penna, o
rinnovate, non sappiamo praticamente nulla, a cominciare dalla stessa chiesa di San
Cristoforo in cui si trova la nostra Madonna. Con questo vorrei sottolineare che
l’impresa della nuova edicola, pur eccezionale per quanto riguarda il livello,
partecipa ad un clima culturale particolare, che definirei ufficiale, che si cercava di
radicare nella zona grazie a interventi diretti della corte (o di cortigiani: gli Oliva,
nel nostro caso), o indiretti, cioè con consigli, suggerimenti, consulenze di artisti e
artigiani ducali. Sembra, però, che localmente non ci si sia mai sentiti troppo legati da
questi dettami di politica artistica. Un esempio di tale indipendenza può essere
segnalato fin dal 1533, quando per la commissione di una tavola raffigurante San Sireno
(un santo collegato dai pennesi proprio al culto della Madonna delle Grazie) ci si
rivolse, seguendo una vecchia consuetudine, alla solita bottega riminese dei Coda.
Naturalmente non sappiamo dire se si trattò di una scelta polemica o semplicemente di uno
dei tanti sintomi della gravitazione naturale di Pennabilli verso la bassa valle del
Marecchia. Certo anche in seguito, nel corso del XVI e XVII secolo, vi troviamo opere
d’arte provenienti dalla Romagna, dall’Umbria e dalla Toscana: ma soprattutto vi
troviamo opere marchigiane. Marchigiano, anche se con notevoli influenze emiliano
romagnole, sembra il diligente pittore che intorno alla metà del XVI secolo ha dipinto la
pala della Resurrezione in questa stessa chiesa di San Cristoforo, da tenere
particolarmente presente perché alcuni dei santi che vi sono raffigurati potevano essere
quelli originariamente dipinti accanto alla Madonna delle Grazie, cancellati nel 1528
durante la costruzione dell’edicola. E perché appartiene alla stessa corrente
dell’artista che ha affrescato le scene eucaristiche di fianco al nuovo
tabernacolo della Madonna, scoperte con la recente rimozione delle parti lignee e con
l’attuale restauro, ma che non hanno niente a che fare con esso né dal punto di
vista concettuale, né da quello formale. Il Marchigiano è anche il pittore che ha
dipinto, sempre per questa chiesa, una splendida e sciupata Adorazione dei Magi che
si dimostra ricca di elementi di cultura simili a quelli del pittore dell’edicola
della Madonna, per quanto maturati dal tempo e da contatti nordici: sembra molto vicino al
fanese Giuliano Presutti nella sua attività tarda: la sua Sant’Orsola di
Ancona del 1554, infatti, si confronta abbastanza bene col nostro dipinto, che dovrebbe
risalire alla metà del secolo.
 Dal 1568 siamo molto meglio informati
sulle vicende artistiche che ruotano attorno alla nostra immagine miracolosa grazie ad
alcuni libri superstiti della compagnia della Madonna delle Grazie, diligentemente
esplorati per questa occasione da Girolamo Allegretti, dei cui appunti liberalmente
concessi mi avvalgo ampiamente. Fra il 1569 e il 1571 vi troviamo annotata tutta una serie
di piccoli lavori di restauro e di doratura compiuti all’altare da un pittore
pennese, Piero Andrea, che dipinse anche una cortina posta davanti alla Madonna. Questo
pittore non è ignoto alla letteratura locale, che lo colloca intorno alla metà del
Cinquecento, gli dà il cognome di Saraceni ed il soprannome di Fabbri, lo dice scolaro,
naturalmente «eccellente», di Tiziano e gli attribuisce opere a Venezia, Ravenna,
Rimini, San Leo e Pennabilli. Tutte ignote, purtroppo, tanto da far sospettare un qualche
equivoco (con il ben più celebre pittore veneziano Carlo Saraceni, per esempio). In ogni
caso dai nostri documenti risulta soprattutto un decoratore, un piccolo pittore artigiano.
Certo non l’unico del paese, dove lo affianca un Claudio Saraceno, forse fratello o
figlio, anch’esso decoratore, che muore nel 1601. C’è poco da segnalare fino
all’inizio del secolo, quando troviamo pagamenti per l’«ornamento, ovvero
ancona della Madonna» ad un certo maestro Clemente da Santarcangelo. Il lavoro fu
eseguito a Santarcangelo e finito di trasportare a Pennabilli il 5 novembre 1600. A
Pennabilli fu incaricato di decorarlo e dorarlo il maestro Claudio Saraceno appena citato.
Fortunatamente quest’opera è giunta fino a noi, anche se in non buone condizioni:
un auspicabile restauro, ormai indispensabile per la sua conservazione, sarebbe utile
anche per verificare se le belle decorazioni - costituite da un arabesco dipinto in blu e
rosso sull’oro - sono ancora quelle eseguite dal Saraceni. Si tratta di una grande
ancona lignea interamente dorata; essa sostituiva la cornice rinascimentale e nascondeva
completamente gli affreschi, ormai considerati vecchi e inadeguati, perchè riempiva tutta
la parete di fondo dell’edicola. È fastosa e complicata, di gusto tardo manierista
nella confusa partizione e frantumazione degli ordini classici, ma piacevole e ricca. Il
suo autore è uno dei tanti piccoli maestri, quasi subito dimenticati, attivi in quel
periodo in molti centri della Romagna e delle Marche, partecipi di quel grande momento
veramente internazionale che fu l’ultimo manierismo. Ora, privata da un furto delle
statuette che decoravano le sue due piccole nicchie, è provvisoriamente collocata
nell’abside della chiesa di San Cristoforo. Non sappiamo per quali motivi i Pennesi
si sono rivolti ad un artista di Santarcangelo, ma probabilmente in quel momento egli era
uno dei più famosi della zona: purtroppo non sappiamo niente di lui e delle sue opere,
tranne che aveva appena eseguito un lavoro analogo anche per la chiesa abbaziale dei
Benedettini di Cesena. Certo non si servirono di lui solo per comodità; del resto sembra
che le loro scelte non siano mai state di comodo. Lo dimostra anche il fatto che per una
copertina ricamata da porre davanti alla Vergine, pochi anni dopo, si siano rivolti
addirittura a Napoli, senza preoccuparsi per l’aggiunta di spese e di fastidi. Nel
1616 da Napoli, appunto, arrivò la prima delle «vesti» documentate della Madonna, tutta
finemente ricamata d’oro su tela d’argento, con un policromo Padre Eterno
benedicente fra le nubi e rabeschi sottili e sinuosi di grande effetto. Posta
davanti all’affresco permetteva di vedere solo i volti delle due figure divine, un
po’ come le copertine d’argento delle icone, secondo un uso largamente diffuso,
inteso a proteggere e nello stesso tempo ad arricchire l’immagine. A questa data il
monumento si poteva considerare veramente completo; era anche già circondato dalla bella
cancellata ancora esistente, con motivi a cuore (e a gigli) di rinascimentale eleganza,
eseguita nel 1606 probabilmente da un Francesco magnano; inoltre nel 1607 era stato
decorato con un fregio, forse applicato nell’imbotte dell’arco, del pittore
Marco Bistolli, un giovane confratello incaricato anche di dirigere l’apparato per il
«venerdì bello» del 1608. L’insieme doveva avere un aspetto armonico e sontuoso:
ma non abbastanza per i confratelli, che per abbellire ulteriormente l’altare della
loro Madonna miracolosa tenevano d’occhio quanto si faceva di meglio nelle chiese dei
dintorni. L’attenzione era rivolta particolarmente alle grandi macchine lignee,
scintillanti di dorature, che rivestivano interi oratori, come quello del Nome di Dio a
Pesaro; o costruite dietro agli altari per inquadrare le nuove pale, come quella
attualmente all’altare del Rosario in cattedrale; oppure ai grandi tabernacoli che
venivano costruiti al centro delle tribune, in forma di templi sontuosi; o ancora alle
mostre d’organo erette nelle chiese maggiori, come quella di San Cristoforo, del
1587. Nel 1621 si chiedeva al maestro che aveva fatto un tabernacolo a Maciano (non
sappiamo però in quale chiesa) di compiere un sopralluogo all’altare della Madonna
per vedere se era possibile accrescerne o migliorarne l’ornato. Purtroppo non
sappiamo niente di questo maestro, nè della sua opera, né dei consigli da lui dati ai
priori; ma nel libro della compagnia sono annotate subito dopo alcune spese per ricercare
pietre a Monte Boaggine «per l’ornamento dell’altare», e nel 1623 altre
riguardanti l’inizio e la prosecuzione (anche grazie ad un buon lascito)
dell’«aumento» dell’altare. Ma quale maestro vi stava lavorando? Lo stesso che
aveva eseguito lo sconosciuto tabernacolo di Maciano? Forse si trattava di un maestro
di Foligno, perché nel verbale della congregazione del 2 febbraio 1625 troviamo
annotato: «Fu ricordato che si faccino venire le statue per i nicchi et altri ornamenti
non perfetti dal maestro intagliatore di Fuligno».
Dal 1568 siamo molto meglio informati
sulle vicende artistiche che ruotano attorno alla nostra immagine miracolosa grazie ad
alcuni libri superstiti della compagnia della Madonna delle Grazie, diligentemente
esplorati per questa occasione da Girolamo Allegretti, dei cui appunti liberalmente
concessi mi avvalgo ampiamente. Fra il 1569 e il 1571 vi troviamo annotata tutta una serie
di piccoli lavori di restauro e di doratura compiuti all’altare da un pittore
pennese, Piero Andrea, che dipinse anche una cortina posta davanti alla Madonna. Questo
pittore non è ignoto alla letteratura locale, che lo colloca intorno alla metà del
Cinquecento, gli dà il cognome di Saraceni ed il soprannome di Fabbri, lo dice scolaro,
naturalmente «eccellente», di Tiziano e gli attribuisce opere a Venezia, Ravenna,
Rimini, San Leo e Pennabilli. Tutte ignote, purtroppo, tanto da far sospettare un qualche
equivoco (con il ben più celebre pittore veneziano Carlo Saraceni, per esempio). In ogni
caso dai nostri documenti risulta soprattutto un decoratore, un piccolo pittore artigiano.
Certo non l’unico del paese, dove lo affianca un Claudio Saraceno, forse fratello o
figlio, anch’esso decoratore, che muore nel 1601. C’è poco da segnalare fino
all’inizio del secolo, quando troviamo pagamenti per l’«ornamento, ovvero
ancona della Madonna» ad un certo maestro Clemente da Santarcangelo. Il lavoro fu
eseguito a Santarcangelo e finito di trasportare a Pennabilli il 5 novembre 1600. A
Pennabilli fu incaricato di decorarlo e dorarlo il maestro Claudio Saraceno appena citato.
Fortunatamente quest’opera è giunta fino a noi, anche se in non buone condizioni:
un auspicabile restauro, ormai indispensabile per la sua conservazione, sarebbe utile
anche per verificare se le belle decorazioni - costituite da un arabesco dipinto in blu e
rosso sull’oro - sono ancora quelle eseguite dal Saraceni. Si tratta di una grande
ancona lignea interamente dorata; essa sostituiva la cornice rinascimentale e nascondeva
completamente gli affreschi, ormai considerati vecchi e inadeguati, perchè riempiva tutta
la parete di fondo dell’edicola. È fastosa e complicata, di gusto tardo manierista
nella confusa partizione e frantumazione degli ordini classici, ma piacevole e ricca. Il
suo autore è uno dei tanti piccoli maestri, quasi subito dimenticati, attivi in quel
periodo in molti centri della Romagna e delle Marche, partecipi di quel grande momento
veramente internazionale che fu l’ultimo manierismo. Ora, privata da un furto delle
statuette che decoravano le sue due piccole nicchie, è provvisoriamente collocata
nell’abside della chiesa di San Cristoforo. Non sappiamo per quali motivi i Pennesi
si sono rivolti ad un artista di Santarcangelo, ma probabilmente in quel momento egli era
uno dei più famosi della zona: purtroppo non sappiamo niente di lui e delle sue opere,
tranne che aveva appena eseguito un lavoro analogo anche per la chiesa abbaziale dei
Benedettini di Cesena. Certo non si servirono di lui solo per comodità; del resto sembra
che le loro scelte non siano mai state di comodo. Lo dimostra anche il fatto che per una
copertina ricamata da porre davanti alla Vergine, pochi anni dopo, si siano rivolti
addirittura a Napoli, senza preoccuparsi per l’aggiunta di spese e di fastidi. Nel
1616 da Napoli, appunto, arrivò la prima delle «vesti» documentate della Madonna, tutta
finemente ricamata d’oro su tela d’argento, con un policromo Padre Eterno
benedicente fra le nubi e rabeschi sottili e sinuosi di grande effetto. Posta
davanti all’affresco permetteva di vedere solo i volti delle due figure divine, un
po’ come le copertine d’argento delle icone, secondo un uso largamente diffuso,
inteso a proteggere e nello stesso tempo ad arricchire l’immagine. A questa data il
monumento si poteva considerare veramente completo; era anche già circondato dalla bella
cancellata ancora esistente, con motivi a cuore (e a gigli) di rinascimentale eleganza,
eseguita nel 1606 probabilmente da un Francesco magnano; inoltre nel 1607 era stato
decorato con un fregio, forse applicato nell’imbotte dell’arco, del pittore
Marco Bistolli, un giovane confratello incaricato anche di dirigere l’apparato per il
«venerdì bello» del 1608. L’insieme doveva avere un aspetto armonico e sontuoso:
ma non abbastanza per i confratelli, che per abbellire ulteriormente l’altare della
loro Madonna miracolosa tenevano d’occhio quanto si faceva di meglio nelle chiese dei
dintorni. L’attenzione era rivolta particolarmente alle grandi macchine lignee,
scintillanti di dorature, che rivestivano interi oratori, come quello del Nome di Dio a
Pesaro; o costruite dietro agli altari per inquadrare le nuove pale, come quella
attualmente all’altare del Rosario in cattedrale; oppure ai grandi tabernacoli che
venivano costruiti al centro delle tribune, in forma di templi sontuosi; o ancora alle
mostre d’organo erette nelle chiese maggiori, come quella di San Cristoforo, del
1587. Nel 1621 si chiedeva al maestro che aveva fatto un tabernacolo a Maciano (non
sappiamo però in quale chiesa) di compiere un sopralluogo all’altare della Madonna
per vedere se era possibile accrescerne o migliorarne l’ornato. Purtroppo non
sappiamo niente di questo maestro, nè della sua opera, né dei consigli da lui dati ai
priori; ma nel libro della compagnia sono annotate subito dopo alcune spese per ricercare
pietre a Monte Boaggine «per l’ornamento dell’altare», e nel 1623 altre
riguardanti l’inizio e la prosecuzione (anche grazie ad un buon lascito)
dell’«aumento» dell’altare. Ma quale maestro vi stava lavorando? Lo stesso che
aveva eseguito lo sconosciuto tabernacolo di Maciano? Forse si trattava di un maestro
di Foligno, perché nel verbale della congregazione del 2 febbraio 1625 troviamo
annotato: «Fu ricordato che si faccino venire le statue per i nicchi et altri ornamenti
non perfetti dal maestro intagliatore di Fuligno».
 L’accrescimento dell’ornato
consisteva sostanzialmente in due ali lignee, sorrette da colonne scanalate e tortili, che
allargavano sensibilmente il monumento; e in alto da un tamburo poligonale con cupola e da
una balaustra, che davano slancio all’insieme. Il tutto in legno, con nicchie,
statue, cartelle in rilievo, pitture ornamentali e dorature. Le dorature interessarono
anche l’ornato cinquecentesco in pietra, che veniva così a fondersi, ad annullarsi
nella nuova architettura. Dopo questi lavori nessuna delle pitture rinascimentali era più
visibile; anche ciò che rimaneva in vista delle scene eucaristiche dipinte sulla parete a
fianco del monumento venne scialbato in quanto mutilo e quindi insignificante, e in quanto
dannoso alla visibilità del «nuovo monumento»: infatti si può proprio parlare di un
monumento nuovo, del tutto in linea con il gusto seicentesco e con le esigenze della
religiosità controriformistica. L’edicola ora si è trasformata nel simbolo del
tempio di Salomone che custodisce l’arca dell’Alleanza. In alto trionfa la Donna
dell’Apocalisse, regina e mediatrice fra cielo e terra; ai lati dell’arco due
statue rappresentano Santa Monica (? ) e Santa Maria Maddalena, forse in quanto immagini
simboliche di fiducia e di pentimento, e ad esse sono sottoposti gli stemmi della
confraternita; al centro dell’arco, in posizione dominante, compare però lo stemma
della comunità; mentre sul fianco sinistro una scritta a lettere d’oro riassume i
prodigi dell’immagine, sul fianco destro un’altra ricorda la fondazione del
«sacello» nel 1222, il suo restauro «dopo» il 1523, il suo ampliamento nel 1623, al
tempo di Urbano VIII e di Francesco Maria Della Rovere: cioè il primissimo tempo di un
grande pontificato, l’ultimissimo tempo di un glorioso ducato. Nel suo insieme il
nuovo monumento non ha confronti in zona, né per forma, né per qualità, né per
ricchezza. Nelle Marche posso ricordare per qualche analogia solo il fastoso armadio per i
libri sacri della sinagoga di rito italiano di Ancona. Credo che l’artista fosse di
educazione romana: a Roma rimanda anche il manierismo delle due belle statue di Santa
Monica e della Maddalena, di salda impostazione plastica, di elegante movimento e
preziosamente dipinte. A proposito di pitture e dorature, questa volta non sappiamo se
erano state eseguite in loco, come nel caso dell’ancona, ma è probabile; comunque
anche le decorazioni pittoriche sono di buona esecuzione tecnica e di grande bellezza; le
grottesche dei fianchi formano come un prezioso tessuto dai colori caldi, armoniosi e
vivaci. Dopo pochi anni i Confratelli si mettono in movimento per costruire un
soffitto, un cielo in cui far comparire la figura del Padre eterno, necessaria per
completare il senso del monumento {ed infatti sempre presente fino a trent’anni
prima, quando era stata nascosta dall’ancona). Nel 1634 nel libro della compagnia
troviamo annotato: «Si veda di fare il soffitto sopra l’ornamento della Madonna
secondo il disegno inviato dal maestro Orazio Borioni intagliatore de Borgo San
Sepolcro». L’anno successivo il soffitto era già pronto; i lavori di doratura e
pittura durarono fino al 1636. Si tratta di un vero capolavoro di intaglio e di scultura
che rimanda soprattutto ad analoghe opere romane. Mentre gli angeli hanno un’eleganza
raffinata e movenze classicheggianti, la grande figura del Padre Eterno, argentata e
dorata, mostra ancora un rude plasticismo e asprezze arcaizzanti che la apparentano
vagamente a quelle del soffitto dell’oratorio del Gonfalone di Fabriano, eseguito nel
1643 dal francese Leonardo Scaglia, molto attivo fra Umbria e Marche . Chi fosse
l’intagliatore Orazio Borioni che ne aveva fatto il disegno, e al quale credo debba
essere riferita anche l’esecuzione, non sappiamo. Secondo i registri della compagnia
a lui spetta una proposta «di accrescimento delle statue intorno alla cupola e di due
statue in basso»: si tratta degli angeli e delle due statue delle nicchie piccole, che
probabilmente furono eseguite da un altro intagliatore perché sembrano differenziarsi per
il modellato più grossolano tanto da quelle bellissime delle due sante in alto, quanto
dai rilievi del soffitto. Alla stessa mano appartengono quasi sicuramente le teste di cherubini
applicate al tamburo della cupola. In questo momento non è possibile studiare i vari
particolari lignei del monumento, smontati ed immagazzinati in attesa dei restauro;
ma si può già dire con certezza che i quattro angeli che erano sulla balaustra,
due nudi e due vestiti, sono di identica fattura: la notizia di due angeli rubati e
sostituiti, tramandata dal Dominici, o è falsa, come tante altre, o si riferisce ad altri
angeli.
L’accrescimento dell’ornato
consisteva sostanzialmente in due ali lignee, sorrette da colonne scanalate e tortili, che
allargavano sensibilmente il monumento; e in alto da un tamburo poligonale con cupola e da
una balaustra, che davano slancio all’insieme. Il tutto in legno, con nicchie,
statue, cartelle in rilievo, pitture ornamentali e dorature. Le dorature interessarono
anche l’ornato cinquecentesco in pietra, che veniva così a fondersi, ad annullarsi
nella nuova architettura. Dopo questi lavori nessuna delle pitture rinascimentali era più
visibile; anche ciò che rimaneva in vista delle scene eucaristiche dipinte sulla parete a
fianco del monumento venne scialbato in quanto mutilo e quindi insignificante, e in quanto
dannoso alla visibilità del «nuovo monumento»: infatti si può proprio parlare di un
monumento nuovo, del tutto in linea con il gusto seicentesco e con le esigenze della
religiosità controriformistica. L’edicola ora si è trasformata nel simbolo del
tempio di Salomone che custodisce l’arca dell’Alleanza. In alto trionfa la Donna
dell’Apocalisse, regina e mediatrice fra cielo e terra; ai lati dell’arco due
statue rappresentano Santa Monica (? ) e Santa Maria Maddalena, forse in quanto immagini
simboliche di fiducia e di pentimento, e ad esse sono sottoposti gli stemmi della
confraternita; al centro dell’arco, in posizione dominante, compare però lo stemma
della comunità; mentre sul fianco sinistro una scritta a lettere d’oro riassume i
prodigi dell’immagine, sul fianco destro un’altra ricorda la fondazione del
«sacello» nel 1222, il suo restauro «dopo» il 1523, il suo ampliamento nel 1623, al
tempo di Urbano VIII e di Francesco Maria Della Rovere: cioè il primissimo tempo di un
grande pontificato, l’ultimissimo tempo di un glorioso ducato. Nel suo insieme il
nuovo monumento non ha confronti in zona, né per forma, né per qualità, né per
ricchezza. Nelle Marche posso ricordare per qualche analogia solo il fastoso armadio per i
libri sacri della sinagoga di rito italiano di Ancona. Credo che l’artista fosse di
educazione romana: a Roma rimanda anche il manierismo delle due belle statue di Santa
Monica e della Maddalena, di salda impostazione plastica, di elegante movimento e
preziosamente dipinte. A proposito di pitture e dorature, questa volta non sappiamo se
erano state eseguite in loco, come nel caso dell’ancona, ma è probabile; comunque
anche le decorazioni pittoriche sono di buona esecuzione tecnica e di grande bellezza; le
grottesche dei fianchi formano come un prezioso tessuto dai colori caldi, armoniosi e
vivaci. Dopo pochi anni i Confratelli si mettono in movimento per costruire un
soffitto, un cielo in cui far comparire la figura del Padre eterno, necessaria per
completare il senso del monumento {ed infatti sempre presente fino a trent’anni
prima, quando era stata nascosta dall’ancona). Nel 1634 nel libro della compagnia
troviamo annotato: «Si veda di fare il soffitto sopra l’ornamento della Madonna
secondo il disegno inviato dal maestro Orazio Borioni intagliatore de Borgo San
Sepolcro». L’anno successivo il soffitto era già pronto; i lavori di doratura e
pittura durarono fino al 1636. Si tratta di un vero capolavoro di intaglio e di scultura
che rimanda soprattutto ad analoghe opere romane. Mentre gli angeli hanno un’eleganza
raffinata e movenze classicheggianti, la grande figura del Padre Eterno, argentata e
dorata, mostra ancora un rude plasticismo e asprezze arcaizzanti che la apparentano
vagamente a quelle del soffitto dell’oratorio del Gonfalone di Fabriano, eseguito nel
1643 dal francese Leonardo Scaglia, molto attivo fra Umbria e Marche . Chi fosse
l’intagliatore Orazio Borioni che ne aveva fatto il disegno, e al quale credo debba
essere riferita anche l’esecuzione, non sappiamo. Secondo i registri della compagnia
a lui spetta una proposta «di accrescimento delle statue intorno alla cupola e di due
statue in basso»: si tratta degli angeli e delle due statue delle nicchie piccole, che
probabilmente furono eseguite da un altro intagliatore perché sembrano differenziarsi per
il modellato più grossolano tanto da quelle bellissime delle due sante in alto, quanto
dai rilievi del soffitto. Alla stessa mano appartengono quasi sicuramente le teste di cherubini
applicate al tamburo della cupola. In questo momento non è possibile studiare i vari
particolari lignei del monumento, smontati ed immagazzinati in attesa dei restauro;
ma si può già dire con certezza che i quattro angeli che erano sulla balaustra,
due nudi e due vestiti, sono di identica fattura: la notizia di due angeli rubati e
sostituiti, tramandata dal Dominici, o è falsa, come tante altre, o si riferisce ad altri
angeli.
 Questi
sono stati gli ultimi lavori veramente importanti che riguardano il monumento nel suo
insieme; nella sostanza infatti nulla vi verrà aggiunto o tolto, nulla ne muterà
l’aspetto. A questo punto può essere interessante leggere la descrizione di un
illustre e devoto contemporaneo, don Pier Antonio Guerrieri: «... sontuoso adornamento in
forma di Castello, e di pomposo Tabernacolo con bel disegno, e ricca manifattura di
legname indorato e d’Historie variamente intagliate. Sopra la qual machina in alto si
apre un Regio Baldacchino di fino lavoro d’intagli tutto messo a oro». Più barocca,
e più in linea col gusto del suo tempo, è la descrizione del padre agostiniano Michele
Vanzi: «Questo altare rappresenta la forma di Carro Trionfale, quale con vaga, e
industriosa architettura è fabricato, e di non ordinarie statue adorno. Di sopra da
ricchissimo Baldachino di mirabile scultura ricoperto; si scopre dalla sommità fino a
terra tutto ricoperto d’oro; quale con diligente cura di quei zelanti Fratelli vien
custodito: Nel mezzo di quello, come in seggio elevato, si vede della Regina degli Angeli
la gloriosissima, e miracolosissima Imagine». Nemmeno fra le righe vi si può scorgere un
qualche rammarico per il sacello rinascimentale nascosto ed anzi annullato dalle
trasformazioni barocche: i problemi della storia, della filologia, del restauro sono
problemi essenzialmente moderni, e toccherà a noi risolverli. In seguito ai lavori di
accrescimento dell’altare della Madonna, per una sorta di imitazione ed emulazione,
si compirono a Pennabilli diversi lavori in legno di grande impegno, che ne riecheggiano
lo stile e la sontuosità. Primo fra gli altri, già nel 1636, il tabernacolo che sta
sull’altar maggiore della stessa chiesa di San Cristoforo, a cura della
compagnia del Santissimo Sacramento e con il contributo della compagnia della Madonna
delle Grazie. Si tratta di una macchina bellissima, di struttura semplice, di un
manierismo tutto rinascimentale, sviluppata in altezza e complicata da aggiunte di
elementi architettonici e da decorazioni in rilievo ormai di gusto barocco, dorata e
dipinta in rosso e in blu secondo la tradizione; sontuosa e slanciata, è un
‘arredo’ architettonico di grande impatto visivo, oltre che di notevole
significato simbolico. Non sembra avere parenti prossimi in Romagna, ma ne ha
nell’Italia settentrionale e forse nelle Marche meridionali. Anche il tabernacolo
fatto fare da monsignor Bernardino Scala qualche decennio dopo, verso il 1660, per la
cattedrale, ma oggi collocato, mutilo e diviso in due parti, in fondo alla chiesa di San
Cristoforo, è di grande bellezza nelle sue forme più dichiaratamente barocche; il
Guerrieri lo lodava come «Macchina sontuosa di gran vaghezza, e di lavoro Jonio, Corintio
e Dorico con indoratura Maestrevole e al tutto vistoso, che non credo ne sia un altro di
tal pregio da cento miglia intorno eccetto quello di S. Agostino d’Ancona». Il
riferimento al perduto tabernacolo degli Agostiniani di Ancona è senza dubbio
interessante: potrebbero essere stati appunto gli Agostiniani, a cui apparteneva la
chiesa di San Cristoforo, gli abili registi di tutte le imprese ‘lignarìe'
che hanno ruotato attorno al monumento della Madonna delle Grazie ed all’altar
maggiore della loro chiesa, custodito ed amministrato dalla Confraternita del Santissimo
Sacramento. D’altra parte si doveva alla loro iniziativa anche l’organo
cinquecentesco citato precedentemente, con l’imponente cassa lignea di forme
classicheggianti, dorata, rabescata, e finemente ornata di grottesche. Comunque a
Pennabilli il gusto per le suppellettili lignee intagliate e dorate sembra aver perdurato
a lungo, come dimostrano molti ottimi pezzi raccolti nel Museo Diocesano. Fra tutti va
ricordata in questa occasione un’inedita e stupenda Madonna lignea a tutto tondo, ora
scorticata, mutila e montata su un seggiolone barocco da processione, perché potrebbe
essere opera degli stessi artisti che hanno lavorato all’altare della Madonna delle
Grazie: comunque credo si tratti di un unicum per il territorio feltresco, almeno
per quanto riguarda la qualità. Forse solo a conclusione di tutti questi lavori fu
dipinta la tenda ancor oggi conservata nell’ancona della Madonna, che aveva la
funzione di nascondere l’antica immagine miracolosa «come sacra e pretiosissima
Reliquia, che non si scopre se non per le solenni feste e gravi occasioni, e per la sua
anniversaria solennità, che si celebra il terzo Venerdì di Marzo per memoria del prodigioso
miracolo delle sue lacrime», come scriveva il Guerrieri. Questa tenda raffigura
l’Immacolata Concezione, ed è una copia mediocre, per quanto abbastanza fedele, di
quella forlivese di Guido Reni; il Dominici la riferisce con sicurezza a Marco Bistolli e
ne cita con precisione la data di allogazione: 10 febbraio 1616. Ma qualcosa non quadra,
perché a quella data Marco Bistolli era già morto, e inoltre l’originale del Reni
non era stato ancora dipinto. Ad un momento successivo alla conclusione dei lavori va
riferita anche una tela raffigurante l’assedio di Pennabilli e l’apparizione
miracolosa della Madonna, purtroppo ora mutila della sua iscrizione, un tempo posta di
fronte al monumento forse come sovrapporta della sagrestia. Nonostante venga spesso
considerata coeva al miracolo che descrive, deve essere stata eseguita verso la metà del
XVII secolo: non si tratta dunque di un dipinto propriamente votivo, come potrebbe
sembrare, ma commemorativo. Credo possa essere attribuito al pittore pennese Giovanni
Bistolli (terzo, con il già citato Marco ed il meglio noto Giulio, di questa famiglia),
considerando che mostra qualche affinità con le lunette affrescate del chiostro di
Maciano (raffiguranti episodi della vita di San Francesco), datate al 1656-59, che
costituiscono un testo fondamentale per la ricostruzione della sua personalità, ma che
sono fortemente deperite ed ora anche insidiate dal crollo degli intonaci e delle volte
stesse. L’immagine miracolosa ed il suo altare sono stati oggetto di molti piccoli
interventi anche in seguito, ma nessuno di essi ne ha modificato sostanzialmente
l’aspetto. Questo non significa necessariamente una caduta di interesse devozionale
per la Madonna delle Grazie; considerato ormai completo l’altare, l’attenzione e
gli ‘investimenti’ dei fedeli e della Compagnia si rivolsero ad altri fatti:
prima di tutto la diffusione del suo culto, poi l’incoronazione ufficiale
dell’immagine, l’arricchimento e l’ammodernamento degli arredi e via
dicendo. Attorno alla Madonna delle Grazie continuarono dunque a fiorire imprese
artistiche di vario livello e di varia importanza: nuove «vesti» per
l’immagine, nuovi paliotti per l’altare, nuove suppellettili liturgiche. Qui è
impossibile dar conto puntualmente di tutto questo fervore. Ma bisogna ricordare almeno
un’opera d’eccezione: una «veste» in lamina d’argento parzialmente
dorata, la cui manifattura impegnò la Compagnia per molti anni. La sua storia è lunga;
comincia nel maggio del 1721 con il ricalco su carta della Madonna e del profilo della sua
cornice centinata, per ricavarne la «forma» da inviare a Roma ad un argentiere, forse
per un preventivo. L’operazione, eseguita con poca esattezza, viene ripetuta due anni
dopo; ma forse il lavoro era troppo costoso, e così nel 1727 si ripiegò su due coroncine
d’argento in sostituzione di quelle d’oro (con cui era stata ufficialmente
incoronata nel 1708), riservate prudentemente solo alle massime solennità. L’idea
però venne ripresa nel 1730, quando troviamo già consegnata ad un maestro argentiere di
Roma una consistente caparra. Solo il 4 gennaio del l734 «giunse alla Penna la veste
d’argento lavorata in Roma per la nostra Beata Vergine, et inviata dal sig. abbate
Francesco Marcelli da Roma per il vetturale Giuseppe Mancini lavoratore de signori
Olivieri di Lunano. Pesò con la cassa lib. 110 et ebbe il suddetto per sua mercede in
tutto paoli 40, cioè paoli 22 per il peso suddetto a ragione di baj. 2 per libra, paoli
15 così concordati oltre l’importo del detto peso, e paoli 3 per ben’andata per
essergli convenuto pernottare qui alla Penna con la bestia». Era stata eseguita, ci
informa un’annotazione successiva, da un certo «Stefano Francois argentiere», di
cui abbiamo poche notizie e soprattutto di cui conosciamo pochi altri lavori: era romano,
anche se forse discendeva da una delle tante famiglie di artigiani e artisti francesi che
si erano stabilite nella capitale nel secolo precedente, e prima di diventare maestro
argentiere «all'insegna del delfino» (1710) aveva fatto l’ottonaro
«all’insegna del mondo d’oro». La partita riguardante questa aveste»
d’argento fu chiusa solo nel 1736 con doni di prosciutti e danaro agli amici e ai
compaesani che a Roma si erano dati da fare con gli argentieri e i doganieri perchè il
tutto andasse a buon fine: «per piccola ricognizione delle fatiche da essi fatte per
sopraintendere al lavoro della veste d’argento venuta sin dall’anno scorso, e
procurar di cavarla di mano all’argentiere che diede molto da temere». Cosa avessero
da temere i confratelli pennesi non si sa, ma si può immaginare notando che il manufatto
d’argento è pervenuto a Pennabilli nell’anno stesso in cui l’argentiere è
morto: forse si ebbe qualche difficoltà ad ottenerla dai parenti durante la malattia
dell’artista; ma soprattutto va notato che non reca né i bolli di garanzia camerali,
né quelli della bottega dell’argentiere: forse per risparmiare su qualche tassa e
qualche dazio il lavoro fu esportato illegalmente, col grave pericolo di farselo
confiscare. Certamente eludendo ai controlli la compagnia rischiava anche di avere un
prodotto scadente per quanto riguardava la qualità del metallo; ma forse si ritenne
opportuno rischiare e perché i tempi calamitosi costringevano al risparmio, e perché le
tasse da pagare al lontano governo di Roma sembravano più inique di quelle pagate un
tempo al governo del duca. Contrariamente ad altre suppellettili preziose questa «veste»
è scampata alle requisizioni napoleoniche (forse proprio per la mancanza dei bolli di
garanzia) e ci è giunta in discreto stato; costituisce uno dei pezzi più
pregevoli del piccolo «tesoro» della Madonna delle Grazie, sia per quanto riguarda la
materia, sia per quanto riguarda la lavorazione, abbastanza buona anche se non
eccezionale, condotta secondo i moduli tipici del tardo barocco romano. Fino a pochi anni
fa, e quindi per due secoli, durante le ricorrenze solenni la Madonna delle Grazie si
presentava ai fedeli scintillante come una preziosa icona in questa sua veste
d’argento che la faceva apparire ancora più dolce e misteriosa, «d’aspetto
venerabile e pietosa vista». Questa breve storia, o meglio questa breve raccolta di dati,
non ha bisogno di particolari conclusioni: vi emerge da sé, infatti, l’importanza
dell’immagine miracolosa della Madonna delle Grazie come stimolo per la cultura
artistica
Questi
sono stati gli ultimi lavori veramente importanti che riguardano il monumento nel suo
insieme; nella sostanza infatti nulla vi verrà aggiunto o tolto, nulla ne muterà
l’aspetto. A questo punto può essere interessante leggere la descrizione di un
illustre e devoto contemporaneo, don Pier Antonio Guerrieri: «... sontuoso adornamento in
forma di Castello, e di pomposo Tabernacolo con bel disegno, e ricca manifattura di
legname indorato e d’Historie variamente intagliate. Sopra la qual machina in alto si
apre un Regio Baldacchino di fino lavoro d’intagli tutto messo a oro». Più barocca,
e più in linea col gusto del suo tempo, è la descrizione del padre agostiniano Michele
Vanzi: «Questo altare rappresenta la forma di Carro Trionfale, quale con vaga, e
industriosa architettura è fabricato, e di non ordinarie statue adorno. Di sopra da
ricchissimo Baldachino di mirabile scultura ricoperto; si scopre dalla sommità fino a
terra tutto ricoperto d’oro; quale con diligente cura di quei zelanti Fratelli vien
custodito: Nel mezzo di quello, come in seggio elevato, si vede della Regina degli Angeli
la gloriosissima, e miracolosissima Imagine». Nemmeno fra le righe vi si può scorgere un
qualche rammarico per il sacello rinascimentale nascosto ed anzi annullato dalle
trasformazioni barocche: i problemi della storia, della filologia, del restauro sono
problemi essenzialmente moderni, e toccherà a noi risolverli. In seguito ai lavori di
accrescimento dell’altare della Madonna, per una sorta di imitazione ed emulazione,
si compirono a Pennabilli diversi lavori in legno di grande impegno, che ne riecheggiano
lo stile e la sontuosità. Primo fra gli altri, già nel 1636, il tabernacolo che sta
sull’altar maggiore della stessa chiesa di San Cristoforo, a cura della
compagnia del Santissimo Sacramento e con il contributo della compagnia della Madonna
delle Grazie. Si tratta di una macchina bellissima, di struttura semplice, di un
manierismo tutto rinascimentale, sviluppata in altezza e complicata da aggiunte di
elementi architettonici e da decorazioni in rilievo ormai di gusto barocco, dorata e
dipinta in rosso e in blu secondo la tradizione; sontuosa e slanciata, è un
‘arredo’ architettonico di grande impatto visivo, oltre che di notevole
significato simbolico. Non sembra avere parenti prossimi in Romagna, ma ne ha
nell’Italia settentrionale e forse nelle Marche meridionali. Anche il tabernacolo
fatto fare da monsignor Bernardino Scala qualche decennio dopo, verso il 1660, per la
cattedrale, ma oggi collocato, mutilo e diviso in due parti, in fondo alla chiesa di San
Cristoforo, è di grande bellezza nelle sue forme più dichiaratamente barocche; il
Guerrieri lo lodava come «Macchina sontuosa di gran vaghezza, e di lavoro Jonio, Corintio
e Dorico con indoratura Maestrevole e al tutto vistoso, che non credo ne sia un altro di
tal pregio da cento miglia intorno eccetto quello di S. Agostino d’Ancona». Il
riferimento al perduto tabernacolo degli Agostiniani di Ancona è senza dubbio
interessante: potrebbero essere stati appunto gli Agostiniani, a cui apparteneva la
chiesa di San Cristoforo, gli abili registi di tutte le imprese ‘lignarìe'
che hanno ruotato attorno al monumento della Madonna delle Grazie ed all’altar
maggiore della loro chiesa, custodito ed amministrato dalla Confraternita del Santissimo
Sacramento. D’altra parte si doveva alla loro iniziativa anche l’organo
cinquecentesco citato precedentemente, con l’imponente cassa lignea di forme
classicheggianti, dorata, rabescata, e finemente ornata di grottesche. Comunque a
Pennabilli il gusto per le suppellettili lignee intagliate e dorate sembra aver perdurato
a lungo, come dimostrano molti ottimi pezzi raccolti nel Museo Diocesano. Fra tutti va
ricordata in questa occasione un’inedita e stupenda Madonna lignea a tutto tondo, ora
scorticata, mutila e montata su un seggiolone barocco da processione, perché potrebbe
essere opera degli stessi artisti che hanno lavorato all’altare della Madonna delle
Grazie: comunque credo si tratti di un unicum per il territorio feltresco, almeno
per quanto riguarda la qualità. Forse solo a conclusione di tutti questi lavori fu
dipinta la tenda ancor oggi conservata nell’ancona della Madonna, che aveva la
funzione di nascondere l’antica immagine miracolosa «come sacra e pretiosissima
Reliquia, che non si scopre se non per le solenni feste e gravi occasioni, e per la sua
anniversaria solennità, che si celebra il terzo Venerdì di Marzo per memoria del prodigioso
miracolo delle sue lacrime», come scriveva il Guerrieri. Questa tenda raffigura
l’Immacolata Concezione, ed è una copia mediocre, per quanto abbastanza fedele, di
quella forlivese di Guido Reni; il Dominici la riferisce con sicurezza a Marco Bistolli e
ne cita con precisione la data di allogazione: 10 febbraio 1616. Ma qualcosa non quadra,
perché a quella data Marco Bistolli era già morto, e inoltre l’originale del Reni
non era stato ancora dipinto. Ad un momento successivo alla conclusione dei lavori va
riferita anche una tela raffigurante l’assedio di Pennabilli e l’apparizione
miracolosa della Madonna, purtroppo ora mutila della sua iscrizione, un tempo posta di
fronte al monumento forse come sovrapporta della sagrestia. Nonostante venga spesso
considerata coeva al miracolo che descrive, deve essere stata eseguita verso la metà del
XVII secolo: non si tratta dunque di un dipinto propriamente votivo, come potrebbe
sembrare, ma commemorativo. Credo possa essere attribuito al pittore pennese Giovanni
Bistolli (terzo, con il già citato Marco ed il meglio noto Giulio, di questa famiglia),
considerando che mostra qualche affinità con le lunette affrescate del chiostro di
Maciano (raffiguranti episodi della vita di San Francesco), datate al 1656-59, che
costituiscono un testo fondamentale per la ricostruzione della sua personalità, ma che
sono fortemente deperite ed ora anche insidiate dal crollo degli intonaci e delle volte
stesse. L’immagine miracolosa ed il suo altare sono stati oggetto di molti piccoli
interventi anche in seguito, ma nessuno di essi ne ha modificato sostanzialmente
l’aspetto. Questo non significa necessariamente una caduta di interesse devozionale
per la Madonna delle Grazie; considerato ormai completo l’altare, l’attenzione e
gli ‘investimenti’ dei fedeli e della Compagnia si rivolsero ad altri fatti:
prima di tutto la diffusione del suo culto, poi l’incoronazione ufficiale
dell’immagine, l’arricchimento e l’ammodernamento degli arredi e via
dicendo. Attorno alla Madonna delle Grazie continuarono dunque a fiorire imprese
artistiche di vario livello e di varia importanza: nuove «vesti» per
l’immagine, nuovi paliotti per l’altare, nuove suppellettili liturgiche. Qui è
impossibile dar conto puntualmente di tutto questo fervore. Ma bisogna ricordare almeno
un’opera d’eccezione: una «veste» in lamina d’argento parzialmente
dorata, la cui manifattura impegnò la Compagnia per molti anni. La sua storia è lunga;
comincia nel maggio del 1721 con il ricalco su carta della Madonna e del profilo della sua
cornice centinata, per ricavarne la «forma» da inviare a Roma ad un argentiere, forse
per un preventivo. L’operazione, eseguita con poca esattezza, viene ripetuta due anni
dopo; ma forse il lavoro era troppo costoso, e così nel 1727 si ripiegò su due coroncine
d’argento in sostituzione di quelle d’oro (con cui era stata ufficialmente
incoronata nel 1708), riservate prudentemente solo alle massime solennità. L’idea
però venne ripresa nel 1730, quando troviamo già consegnata ad un maestro argentiere di
Roma una consistente caparra. Solo il 4 gennaio del l734 «giunse alla Penna la veste
d’argento lavorata in Roma per la nostra Beata Vergine, et inviata dal sig. abbate
Francesco Marcelli da Roma per il vetturale Giuseppe Mancini lavoratore de signori
Olivieri di Lunano. Pesò con la cassa lib. 110 et ebbe il suddetto per sua mercede in
tutto paoli 40, cioè paoli 22 per il peso suddetto a ragione di baj. 2 per libra, paoli
15 così concordati oltre l’importo del detto peso, e paoli 3 per ben’andata per
essergli convenuto pernottare qui alla Penna con la bestia». Era stata eseguita, ci
informa un’annotazione successiva, da un certo «Stefano Francois argentiere», di
cui abbiamo poche notizie e soprattutto di cui conosciamo pochi altri lavori: era romano,
anche se forse discendeva da una delle tante famiglie di artigiani e artisti francesi che
si erano stabilite nella capitale nel secolo precedente, e prima di diventare maestro
argentiere «all'insegna del delfino» (1710) aveva fatto l’ottonaro
«all’insegna del mondo d’oro». La partita riguardante questa aveste»
d’argento fu chiusa solo nel 1736 con doni di prosciutti e danaro agli amici e ai
compaesani che a Roma si erano dati da fare con gli argentieri e i doganieri perchè il
tutto andasse a buon fine: «per piccola ricognizione delle fatiche da essi fatte per
sopraintendere al lavoro della veste d’argento venuta sin dall’anno scorso, e
procurar di cavarla di mano all’argentiere che diede molto da temere». Cosa avessero
da temere i confratelli pennesi non si sa, ma si può immaginare notando che il manufatto
d’argento è pervenuto a Pennabilli nell’anno stesso in cui l’argentiere è
morto: forse si ebbe qualche difficoltà ad ottenerla dai parenti durante la malattia
dell’artista; ma soprattutto va notato che non reca né i bolli di garanzia camerali,
né quelli della bottega dell’argentiere: forse per risparmiare su qualche tassa e
qualche dazio il lavoro fu esportato illegalmente, col grave pericolo di farselo
confiscare. Certamente eludendo ai controlli la compagnia rischiava anche di avere un
prodotto scadente per quanto riguardava la qualità del metallo; ma forse si ritenne
opportuno rischiare e perché i tempi calamitosi costringevano al risparmio, e perché le
tasse da pagare al lontano governo di Roma sembravano più inique di quelle pagate un
tempo al governo del duca. Contrariamente ad altre suppellettili preziose questa «veste»
è scampata alle requisizioni napoleoniche (forse proprio per la mancanza dei bolli di
garanzia) e ci è giunta in discreto stato; costituisce uno dei pezzi più
pregevoli del piccolo «tesoro» della Madonna delle Grazie, sia per quanto riguarda la
materia, sia per quanto riguarda la lavorazione, abbastanza buona anche se non
eccezionale, condotta secondo i moduli tipici del tardo barocco romano. Fino a pochi anni
fa, e quindi per due secoli, durante le ricorrenze solenni la Madonna delle Grazie si
presentava ai fedeli scintillante come una preziosa icona in questa sua veste
d’argento che la faceva apparire ancora più dolce e misteriosa, «d’aspetto
venerabile e pietosa vista». Questa breve storia, o meglio questa breve raccolta di dati,
non ha bisogno di particolari conclusioni: vi emerge da sé, infatti, l’importanza
dell’immagine miracolosa della Madonna delle Grazie come stimolo per la cultura
artistica
 pennese: uno stimolo ancora operante, come dimostrano il recente restauro e le
manifestazioni sorte in margine all’attuale celebrazione del V centenario delle
Lacrime; emerge da sé anche la vivacità di tale cultura, non priva di elementi peculiari
e di operatori locali, ma continuamente alimentata ed aggiornata da apporti esterni di
notevole peso, che la rendono varia e non provinciale. Però c’è molto lavoro da
fare per ricuperare il senso di tanto fervore di opere e soprattutto per comprenderne la
genesi e l’orientamento; e per capire come tali opere hanno interagito con le altre,
diversamente motivate, presenti nella città e nel suo territorio, e se, come e quanto
hanno contribuito a creare un sistema organico, una mentalità, una cultura. Pennabilli è
ricca di storia vissuta e non è povera di storie scritte; ma poco della prima si riflette
nelle seconde, per il troppo spazio concesso ai luoghi comuni, alle fantasie, alle
polemiche interpaesane, mentre vi sono state trascurate – ancor più della «sana
critica storica», come si diceva un tempo - la ricerca organica e la riflessione sui dati
positivi. E questi sono negli archivi, che però aspettano ancora di essere riordinati,
resi pienamente pubblici e consultati; ma non solo: sono anche in tanti oggetti d’uso
dimenticati e dispersi, e nel paesaggio, nelle pietre, nei mattoni, negli intonaci, nei
colori «in forma di figure», che aspettano di essere salvati, di essere messi in
condizione di parlare, di essere interrogati con umiltà, con pazienza, con amore. Le
testimonianze d’arte, piccole e grandi, fiorite attorno alla Madonna delle Grazie
sono fra questi: costituiscono documenti preziosi di pietà, di storia, di vita, oltre che
di arte. Il loro riconoscimento, il loro ricupero ed il loro ascolto, appena iniziati, non
possono certo attendere un altro «centenario».
pennese: uno stimolo ancora operante, come dimostrano il recente restauro e le
manifestazioni sorte in margine all’attuale celebrazione del V centenario delle
Lacrime; emerge da sé anche la vivacità di tale cultura, non priva di elementi peculiari
e di operatori locali, ma continuamente alimentata ed aggiornata da apporti esterni di
notevole peso, che la rendono varia e non provinciale. Però c’è molto lavoro da
fare per ricuperare il senso di tanto fervore di opere e soprattutto per comprenderne la
genesi e l’orientamento; e per capire come tali opere hanno interagito con le altre,
diversamente motivate, presenti nella città e nel suo territorio, e se, come e quanto
hanno contribuito a creare un sistema organico, una mentalità, una cultura. Pennabilli è
ricca di storia vissuta e non è povera di storie scritte; ma poco della prima si riflette
nelle seconde, per il troppo spazio concesso ai luoghi comuni, alle fantasie, alle
polemiche interpaesane, mentre vi sono state trascurate – ancor più della «sana
critica storica», come si diceva un tempo - la ricerca organica e la riflessione sui dati
positivi. E questi sono negli archivi, che però aspettano ancora di essere riordinati,
resi pienamente pubblici e consultati; ma non solo: sono anche in tanti oggetti d’uso
dimenticati e dispersi, e nel paesaggio, nelle pietre, nei mattoni, negli intonaci, nei
colori «in forma di figure», che aspettano di essere salvati, di essere messi in
condizione di parlare, di essere interrogati con umiltà, con pazienza, con amore. Le
testimonianze d’arte, piccole e grandi, fiorite attorno alla Madonna delle Grazie
sono fra questi: costituiscono documenti preziosi di pietà, di storia, di vita, oltre che
di arte. Il loro riconoscimento, il loro ricupero ed il loro ascolto, appena iniziati, non
possono certo attendere un altro «centenario».