I PRIMI PADRI DOMENICANI
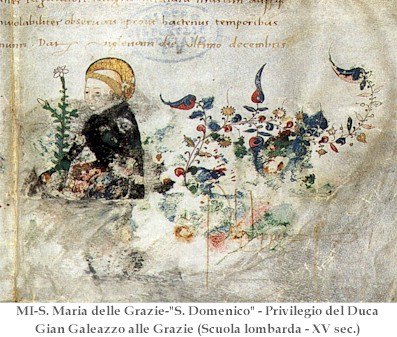 La storia insegna che vi è diretta proporzione fra l’intensità della
vita religiosa in una comunità e il suo livello di promozione non solo cristiano, ma
anche socio-culturale nell’ambiente. Fin dai primi anni, sempre più numerosi i
Milanesi si riversavano fuori porta Vercellina, non solo come devoti pellegrini al primo
santuario mariano cittadino, ma anche per ascoltare i sermoni sempre ispirati alla pietà
e alla sana dottrina dei Domenicani riformati. Non solo
gli edifici crescevano, ma anche i frati per quantità e qualità. Si pensi che prima
della fine del Quattrocento c’erano già tre beati: fra Domenico da Catalogna, il
primo superiore che, non solo aveva fondato l’Ospedale di S. Matteo a Pavia, ma ne
aveva scritto anche le Regole. Quindi fra Giacomo Sestio, il primo "fabbricere",
capomastro di tutta la fondazione: "...correva voce comune che se egli si fosse
assentato da Milano il tutto sarebbe andato in fumo, e nulla si sarebbe fatto...". Il
terzo, beato anche ufficialmente, è fra Sebastiano Maggi, il quale, perché i Milanesi
del centro città potessero ascoltare i nuovi venuti, fece costruire come vicaria, solo
per predicatori, la chiesa di S. Maria della Rosa, dove oggi è l’Ambrosiana. E’
significativo che fra Vincenzo Bandello, priore, poi generale di tutto l’ordine,
fosse amico e consigliere non solo di Ludovico il Moro, ma anche dello stesso Leonardo.
L’importanza religiosa e teologica delle Grazie fu determinata anche dalla presenza
del tribunale dell’Inquisizione, qui trasferito da S. Eustorgio il 17 aprile 1558 da
padre Michele Ghisleri, il futuro Pio V, papa e santo. Il santuario in momenti
difficilissimi sorse come autentico faro luminoso per tutta la cittadinanza.
La storia insegna che vi è diretta proporzione fra l’intensità della
vita religiosa in una comunità e il suo livello di promozione non solo cristiano, ma
anche socio-culturale nell’ambiente. Fin dai primi anni, sempre più numerosi i
Milanesi si riversavano fuori porta Vercellina, non solo come devoti pellegrini al primo
santuario mariano cittadino, ma anche per ascoltare i sermoni sempre ispirati alla pietà
e alla sana dottrina dei Domenicani riformati. Non solo
gli edifici crescevano, ma anche i frati per quantità e qualità. Si pensi che prima
della fine del Quattrocento c’erano già tre beati: fra Domenico da Catalogna, il
primo superiore che, non solo aveva fondato l’Ospedale di S. Matteo a Pavia, ma ne
aveva scritto anche le Regole. Quindi fra Giacomo Sestio, il primo "fabbricere",
capomastro di tutta la fondazione: "...correva voce comune che se egli si fosse
assentato da Milano il tutto sarebbe andato in fumo, e nulla si sarebbe fatto...". Il
terzo, beato anche ufficialmente, è fra Sebastiano Maggi, il quale, perché i Milanesi
del centro città potessero ascoltare i nuovi venuti, fece costruire come vicaria, solo
per predicatori, la chiesa di S. Maria della Rosa, dove oggi è l’Ambrosiana. E’
significativo che fra Vincenzo Bandello, priore, poi generale di tutto l’ordine,
fosse amico e consigliere non solo di Ludovico il Moro, ma anche dello stesso Leonardo.
L’importanza religiosa e teologica delle Grazie fu determinata anche dalla presenza
del tribunale dell’Inquisizione, qui trasferito da S. Eustorgio il 17 aprile 1558 da
padre Michele Ghisleri, il futuro Pio V, papa e santo. Il santuario in momenti
difficilissimi sorse come autentico faro luminoso per tutta la cittadinanza.
L'OSPEDALE DI S. CORONA
Nei suoi pressi nacque l’Ospedale di S. Corona, ancora oggi
esistente. Molto spesso accanto ai conventi degli "osservanti" nasceva un
ospedale o almeno una "spezieria" (farmacia) per i poveri. Già a Pavia a opera
di fra Domenico da Catalogna, primo superiore delle Grazie, e Marco Bottigella era sorto
l’Ospedale San Matteo, in modo un po’ leggendario nacque invece l’Ospedale
di S. Corona.
LA RELIQUIA DELLA CORONA DI SPINE
Di ritorno da un pellegrinaggio in Terra Santa, fra Ambrogio del convento
di Soncino, facendo sosta alle Grazie, aveva mostrato ai confratelli milanesi una preziosa
reliquia, accompagnata anche con lettere di autenticazione: una spina della corona posta
sul capo di Gesù. Ludovico il Moro, venutone a conoscenza, ordinò che tale reliquia
fosse deposta nella sacrestia delle Grazie, ma ottenuto un deciso rifiuto da fra Ambrogio,
per risolvere la questione si pervenne ad una sorta di "prova di Dio". Due
sacerdoti delle due comunità domenicane avrebbero concelebrato una Messa mettendo la
spina sull’altare; alla fine ciascuno, con l’obbligo di non strappare la
reliquia, avrebbe preso una sua estremità. Colui al quale fosse rimasta in mano
l’avrebbe tenuta. Alla prova la spina si spezzò esattamente a metà con grande gioia
delle due comunità e buona pace di Ludovico. Quella reliquia suggerì a fra Stefano da
Seregno, l’idea di chiamare col nome di Santa Corona la Confraternita, da lui
fondata, formata da dodici ricchi signori, per l’assistenza ai malati poveri. I
dodici confratelli, due per porta, si dividevano i diversi compiti: visitavano gli
ammalati, non davano mai denaro, ma beni in natura o medicine, invitavano quelli che
potevano convenire alla loro "spezieria" dove potevano trovare medici,
chirurghi, barbieri e tutto ciò che necessitava alle loro esigenze. Alla chiesa-madre i
con fratelli
chiesero una cappella dove farsi seppellire, celebrare le loro feste, riunirsi per pregare
e per ascoltare le prediche del loro padre spirituale. Più tardi fecero decorare la
cappella, ancor oggi chiamata di Santa Corona, da Gaudenzio Ferrari (1542) con affreschi
della "Passione", mentre Tiziano dipinse la pala con l’"Incoronazione
di spine", poi trafugata da Napoleone a Parigi. Dopo moltissime vicissitudini
l’ospedale vive ancora oggi con sede in corso Italia e nosocomio funzionante a Pietra
Ligure.
fratelli
chiesero una cappella dove farsi seppellire, celebrare le loro feste, riunirsi per pregare
e per ascoltare le prediche del loro padre spirituale. Più tardi fecero decorare la
cappella, ancor oggi chiamata di Santa Corona, da Gaudenzio Ferrari (1542) con affreschi
della "Passione", mentre Tiziano dipinse la pala con l’"Incoronazione
di spine", poi trafugata da Napoleone a Parigi. Dopo moltissime vicissitudini
l’ospedale vive ancora oggi con sede in corso Italia e nosocomio funzionante a Pietra
Ligure.
LA PESTE
Quando il flagello della peste sterminava i cittadini, il popolo accorreva
alle Grazie per cercare salvezza. Tanto che la gratitudine della cittadinanza è ancor
oggi presente nella lapide posta all’ingresso della cappella di S. Maria delle
Grazie. Dopo la soppressione dell’ordine e la cacciata dei Domenicani nel 1799, si
dovette attendere il 1904 perché, grazie all’arcivescovo di Milano Andrea Ferrari, i
frati tornassero, prendendo possesso del complesso, piuttosto disastrato, nel 1911. La
spiritualità che nasce dall’ordine domenicano, chiaramente rappresentata alle
Grazie, è cristocentrica e mariana.
IL CENACOLO DI LEONARDO
Il "Cenacolo" è senza dubbio il vertice del cristocentrismo:
viene scelto il momento della terribile accusa: "In verità vi dico, uno di voi mi
tradirà" (Mt. 26, 20-21) con il Cristo al centro della raffigurazione, punto fisso
nel moto che scuote gli apostoli, bruscamente destati dalla terribile accusa. Gesù parla
con lo sguardo chino, con quel suo stagliarsi sul cielo della finestra alle sue spalle, ma
soprattutto con le mani. La destra che va verso Giuda è contratta, come fosse la mano di
uno che domina uno scatto d’ira; quella sinistra è aperta in segno di donazione. Si
potrebbe leggere in ciò il dogma della duplice natura del
Cristo, inoltre la destra indica un bicchiere di vino (sangue versato), la sinistra un
pezzo di pane (offerto in Comunione). Oggi molti pensano che il tema fondamentale del
"Cenacolo" sia l’Eucarestia.

LA DEVOZIONE A MARIA
Il tema mariano non è solo rappresentato dalla frequentatissima
cappella-santuario della Madonna, ma anche dalle numerose rappresentazioni di Maria
conservate nelle diverse cappelle. Proprio le cappelle gentilizie tracciano l’ultimo
motivo religioso del nostro itinerario. S. Maria delle Grazie è una delle poche chiese
milanesi che accolse tanti numerosi personaggi illustri, che la sceglievano come "secunda
domus" per lo zelante apostolato dei frati, per la loro fervorosa preghiera
liturgica e per la benevolenza che godevano presso tutto il popolo. E' il primo Santuario
mariano cittadino. E' stata dichiarata Basilica da Sua Santità Giovanni Paolo II il 22
giugno 1993, su richiesta dell'Arcivescovo Card. Martini e dei Domenicani.
I SEPOLCRI DEI BENEFATTORI
Il primo chiostro dei conventi domenicani, quello confinante con la
chiesa, era detto "chiostro dei morti" perché in esso venivano sepolti i laici
che lo desideravano; spesso anche la chiesa, oltre a contenere i sepolcri dei religiosi,
veniva utilizzata per le sepolture dei benefattori. In essa fu sepolto il figlio del
Vimercati con la moglie. Cicco Simonetta, uno dei segretari del Moro, venti giorni prima
di essere decapitato espresse il desiderio di esservi sepolto in una cappella da erigere
dedicata alla Trinità.
ALLA VERGINE DELLE GRAZIE
0 Santa Madre del Redentore porta dei cieli,
stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere.
Tu che accogliendo il saluto dell’angelo,
nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo Creatore,
madre sempre vergine, pietà di noi peccatori."
Preghiera scritta sul manto della Madonna delle Grazie
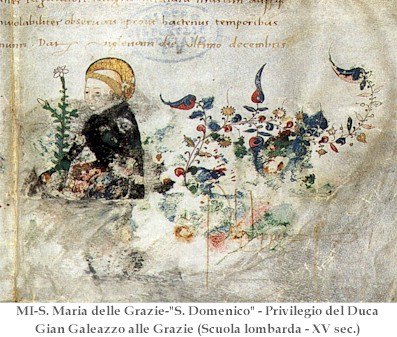 La storia insegna che vi è diretta proporzione fra l’intensità della
vita religiosa in una comunità e il suo livello di promozione non solo cristiano, ma
anche socio-culturale nell’ambiente. Fin dai primi anni, sempre più numerosi i
Milanesi si riversavano fuori porta Vercellina, non solo come devoti pellegrini al primo
santuario mariano cittadino, ma anche per ascoltare i sermoni sempre ispirati alla pietà
e alla sana dottrina dei Domenicani riformati. Non solo
gli edifici crescevano, ma anche i frati per quantità e qualità. Si pensi che prima
della fine del Quattrocento c’erano già tre beati: fra Domenico da Catalogna, il
primo superiore che, non solo aveva fondato l’Ospedale di S. Matteo a Pavia, ma ne
aveva scritto anche le Regole. Quindi fra Giacomo Sestio, il primo "fabbricere",
capomastro di tutta la fondazione: "...correva voce comune che se egli si fosse
assentato da Milano il tutto sarebbe andato in fumo, e nulla si sarebbe fatto...". Il
terzo, beato anche ufficialmente, è fra Sebastiano Maggi, il quale, perché i Milanesi
del centro città potessero ascoltare i nuovi venuti, fece costruire come vicaria, solo
per predicatori, la chiesa di S. Maria della Rosa, dove oggi è l’Ambrosiana. E’
significativo che fra Vincenzo Bandello, priore, poi generale di tutto l’ordine,
fosse amico e consigliere non solo di Ludovico il Moro, ma anche dello stesso Leonardo.
L’importanza religiosa e teologica delle Grazie fu determinata anche dalla presenza
del tribunale dell’Inquisizione, qui trasferito da S. Eustorgio il 17 aprile 1558 da
padre Michele Ghisleri, il futuro Pio V, papa e santo. Il santuario in momenti
difficilissimi sorse come autentico faro luminoso per tutta la cittadinanza.
La storia insegna che vi è diretta proporzione fra l’intensità della
vita religiosa in una comunità e il suo livello di promozione non solo cristiano, ma
anche socio-culturale nell’ambiente. Fin dai primi anni, sempre più numerosi i
Milanesi si riversavano fuori porta Vercellina, non solo come devoti pellegrini al primo
santuario mariano cittadino, ma anche per ascoltare i sermoni sempre ispirati alla pietà
e alla sana dottrina dei Domenicani riformati. Non solo
gli edifici crescevano, ma anche i frati per quantità e qualità. Si pensi che prima
della fine del Quattrocento c’erano già tre beati: fra Domenico da Catalogna, il
primo superiore che, non solo aveva fondato l’Ospedale di S. Matteo a Pavia, ma ne
aveva scritto anche le Regole. Quindi fra Giacomo Sestio, il primo "fabbricere",
capomastro di tutta la fondazione: "...correva voce comune che se egli si fosse
assentato da Milano il tutto sarebbe andato in fumo, e nulla si sarebbe fatto...". Il
terzo, beato anche ufficialmente, è fra Sebastiano Maggi, il quale, perché i Milanesi
del centro città potessero ascoltare i nuovi venuti, fece costruire come vicaria, solo
per predicatori, la chiesa di S. Maria della Rosa, dove oggi è l’Ambrosiana. E’
significativo che fra Vincenzo Bandello, priore, poi generale di tutto l’ordine,
fosse amico e consigliere non solo di Ludovico il Moro, ma anche dello stesso Leonardo.
L’importanza religiosa e teologica delle Grazie fu determinata anche dalla presenza
del tribunale dell’Inquisizione, qui trasferito da S. Eustorgio il 17 aprile 1558 da
padre Michele Ghisleri, il futuro Pio V, papa e santo. Il santuario in momenti
difficilissimi sorse come autentico faro luminoso per tutta la cittadinanza. fratelli
chiesero una cappella dove farsi seppellire, celebrare le loro feste, riunirsi per pregare
e per ascoltare le prediche del loro padre spirituale. Più tardi fecero decorare la
cappella, ancor oggi chiamata di Santa Corona, da Gaudenzio Ferrari (1542) con affreschi
della "Passione", mentre Tiziano dipinse la pala con l’"Incoronazione
di spine", poi trafugata da Napoleone a Parigi. Dopo moltissime vicissitudini
l’ospedale vive ancora oggi con sede in corso Italia e nosocomio funzionante a Pietra
Ligure.
fratelli
chiesero una cappella dove farsi seppellire, celebrare le loro feste, riunirsi per pregare
e per ascoltare le prediche del loro padre spirituale. Più tardi fecero decorare la
cappella, ancor oggi chiamata di Santa Corona, da Gaudenzio Ferrari (1542) con affreschi
della "Passione", mentre Tiziano dipinse la pala con l’"Incoronazione
di spine", poi trafugata da Napoleone a Parigi. Dopo moltissime vicissitudini
l’ospedale vive ancora oggi con sede in corso Italia e nosocomio funzionante a Pietra
Ligure.
