UN CHIRURGO UNIVERSITARIO D’OGGI VALUTA GLI ATTI DEL PROCESSO: “UN REIMPIANTO D’ARTO IN PIENA REGOLA” (prof. Landino Cùgola)
Nel luglio del 1999, in un "Taccuino mariano"— rubrica che ho pubblicato, per anni, su Jesus, il mensile di Famiglia cristiana — davo conto ai lettori di un incontro con un medico specialista in reimpianti di arti. Riproduco qui quella intervista che, mentre da' una singolare conferma al Gran Milagro, sembra confermare anche quanto osservavo nel libro: ci sono ancora molte cose da scoprire in questo mistero di Calanda. (Vittorio Messori)
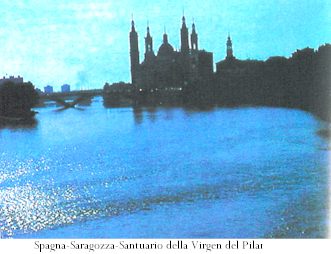
Fra i lettori de Il Miracolo, ce ne è uno che non conoscevo e che ha voluto incontrarmi, rivelandosi subito del tutto speciale. Si tratta del professor Landino Cùgola, traumatologo e docente di microchirurgia nella facoltà di medicina dell'università di Verona. Nel policlinico di quell' ateneo, Cùgola è primario del reparto di chirurgia della mano; ma la sua competenza — e i suoi interventi — si estendono alle traumatologie di tutti gli arti, superiori come inferiori. È uno specialista, conosciuto e apprezzato, nelle nuove tecniche di "reimpianto" di membra che riempiono di stupore noi profani per i loro risultati, inconcepibili anche soltanto pochi anni fa.
Avendo letto su un giornale una recensione del libro, il professore se lo procurò, "divorandolo" (come mi disse poi) anche per interesse professionale. La lettura lo impressionò a tal punto, da mettersi in contatto con me, chiedendomi un incontro. Prima, però, mi chiese di mandargli le fotocopie degli atti completi del processo di Saragozza, con gli interrogatori dei 24 testimoni. Quando ebbe studiato quel dossier, ci vedemmo nel suo studio di primario al policlinico veronese. Subito, volle precisarmi di essere un cattolico piuttosto "sociologico", per tradizione familiare, come capita spesso nel Veneto; dunque, senza particolari interessi né fervori religiosi, anzi portato a una prospettiva laica dalla formazione scientifica e dalla sua professione di chirurgo ai limiti più avanzati. Eppure, volle dirmi, appena ci vedemmo: «Lei si è arreso alla verità dell'evento di Calanda attraverso la strada della ricerca storica. Credo di dovermi arrendere anch'io, seppure attraverso le vie di un medico e di un docente che ogni giorno si occupa di ricostruzione e di reimpianti di arti».
In effetti, mi spiegò che, dopo avere esaminato i documenti processuali, e dopo avere vagliato le testimonianze rese sotto giuramento davanti ai nove giudici di Saragozza, tra il giugno del 1640 e l'aprile del 1641, la conclusione dello specialista moderno non può essere che una sola. Questa, cioè: «Ciò che quegli uomini e quelle donne videro e descrissero non è altro che un reimpianto in piena regola di un arto inferiore destro. In ciò che riferirono — e che fu raccolto e autenticato dai notai — c'è esattamente quanto constatiamo noi specialisti. Ma lo constatiamo oggi, più di tre secoli e mezzo dopo. È assolutamente impensabile che quegli aragonesi del Seicento potessero inventarsi (e con tale precisione!) una situazione clinica e una evoluzione postoperatoria che per essi non era neppure concepibile. L'unica spiegazione oggettivamente possibile è che descrivano ciò che davvero hanno visto. Ma è proprio questa spiegazione che, pur ragionevole, spalanca la porta al mistero!».
Vediamo di seguire le argomentazioni del professor Cùgola. Uno dei problemi con i quali dovettero confrontarsi i severi giudici di Saragozza, fu il fatto che la gamba "riapparsa" al Pellicer presentava un aspetto malandato e che occorse del tempo prima che recuperasse la piena attività e che, anche nelle dimensioni, tornasse identica all'altra. In effetti, qui non si verificò una creazione ex-novo ma, stando ai teologi che hanno riflettuto sul caso, fu dato uno sconvolgente "segno di risurrezione"; o, per meglio dire, di "vita rinnovata".
Dunque, quella sera fatale del 29 marzo del 1640, a quel giovane contadino non "ricrebbe" una gamba nuova, ma gli fu "restituita" quella amputata quasi due anni e mezzo prima quattro dita sotto il ginocchio e sepolta a più di cento chilometri, nel cimitero dell'ospedale di Saragozza. Tutti i testimoni concordano nel dire che sopra la gamba era riscontrabile una serie di segni caratteristici che permettevano l'identificazione.
Però, proprio qui c'è quanto sconcertò maggiormente i giudici chiamati a pronunciarsi sopra il fatto e a giudicarne il carattere soprannaturale. Ricordiamo le parole dell'arcivescovo de Apaolaza nella sentenza con cui si concluse il processo: «La maggior parte dei testimoni hanno deposto che il detto Miguel non fu in grado di rendere stabile immediatamente il suo piede. Aveva infatti i nervi e le dita dei piedi contratti e quasi inservibili e non sentiva il normale calore nella gamba, che appariva di colore cadaverico e non era né lunga né grossa quanto l'altra: tutte cose, queste, che sembrano ripugnare all'essenza del miracolo; sia perché non avvenne in un istante, sia perché una realtà così imperfetta non sembra potere venire da Dio che non conosce opere imperfette...».
L'arcivescovo supera questa obiezione, ricordando che il Dio cristiano interviene direttamente solo là dove la natura, da sola, non può nulla: in questo caso, ridare a qualcuno una gamba che gli abbiano amputata. Fatto questo, il Creatore lascia che agiscano e facciano il loro corso le leggi e le forze che Egli stesso ha creato.
Ma è proprio grazie a questa dinamica "progressiva" del prodigio che Cùgola ha potuto fare le sue considerazioni da traumatologo, da professore universitario di microchirurgia e da specialista in reimpianti di arti.
Innanzitutto, osserva che, ammessa questa "economia divina", questa volontà di Dio di non "strafare", «era nella logica delle cose che la gamba restituita fosse proprio quella amputata al giovane e non un'altra 'nuova'». Solo così, infatti, non era necessario aggiungere un miracolo al miracolo: vincere, cioè, la forza del rigetto. Un rigetto ben conosciuto dai medici specialisti in trapianti: non a caso, molti di loro (e Cùgola è tra questi) si rifiutano di procedere ad operazioni come quella recente di Lione, dove a un australiano furono impiantati la mano e l'avambraccio di un cadavere. Il risultato è che il paziente è costretto ad assumere di continuo potenti e crescenti dosi di farmaci detti "immunosoppressori" per evitare che l'organismo espella l'arto estraneo. Quindi, vi sono chirurghi che accettano di impiantare organi come il cuore o i reni, senza i quali l'alternativa sarebbe la morte, ma non un braccio o una gamba, senza i quali è possibile una vita minorata sì ma forse meno di quanto non accadrebbe con l'assunzione di quelle medicine antirigetto.
Insomma, fa capire il nostro professore, a Calanda Dio non ha voluto aggiungere al miracolo della "riapparizione" di una gamba quello di una sua normalizzazione (superando prodigiosamente le reazioni dell'organismo) che andrebbe, essa pure, contro le forze della natura.
Ma veniamo al quadro clinico descritto dai testimoni e nel quale lo specialista di oggi vede le caratteristiche di un reimpianto in piena regola.
Coloro che deposero davanti al tribunale di Saragozza, si dissero sorpresi per l'aspetto delle dita del piede destro che, subito dopo l'evento, apparivano corbadas bacia abajo, piegate verso il basso, mentre i "nervi" (uno specialista moderno sa che non si tratta di nervi, bensì di tendini, precisa Cùgola) apparivano encogidos, contratti. «E' proprio come deve essere», commenta «In effetti, i muscoli flessori, quelli che terminano nella pianta del piede, sono predominanti, hanno cioè una maggiore capacità di stiramento e hanno una maggior potenza degli estensori, cioè dei muscoli dorsali, situati nella parte superiore del piede. Oggi, infatti, dopo un reimpianto osserviamo che, per un certo tempo, le dita dell'estremità inferiore sono curvate verso il basso e i tendini sono contratti, essendo in tensione».
All'alba del giorno dopo il miracolo, tutto il popolo di Calanda accompagnò in processione Miguel Juan alla chiesa parrocchiale, dove si celebrò la messa e si canto un TeDeum di ringraziamento. Anche qui i testimoni sono unanimi: il giovane lasciò a casa la gamba di legno usata fino ad allora, ma si appoggiò ancora alla sua stampella di mutilato, perché, dicono sempre i testimoni, «non poteva appoggiare a terra il piede destro». Ma già all'uscita dalla chiesa, dopo la lunga liturgia, e sempre più col trascorrere delle ore, la situazione appariva migliorata e migliorò sempre più, fino al punto che la muleta, la stampella, non fu più necessaria. «Anche questo è del tutto normale, per noi specialisti» osserva Cùgola «E' la circolazione, è la vita che, per ritornare nell'arto prima amputato e poi reimpiantato, ha bisogno del suo tempo».
Tra i testimoni fu convocato anche Miguel Escobedo, il sindaco di Calanda, che è il solo che fornisca un curioso particolare. Ecco la citazione testuale della sua deposizione trattata dagli atti del processo: «II deponente (Escobedo), dopo essere stato in chiesa e da lì in avanti sentì dire da Miguel Juan che sentiva calore nella detta gamba destra per cui il deponente gliela toccò e gli fece solletico nella pianta del piede e disse che Miguel Juan lo sentiva e lo vide muovere il piede e le dita. E questo il deponente disse sotto giuramento». Un medico d'oggi che faccia il lavoro di Cùgola non ha invece bisogno di giuramenti, visto che sa bene che anche questo corrisponde al quadro clinico normale che si può osservare dopo un reimpianto.
Rientrano nella normalità pure l'aspetto e l'evoluzione clinica della gamba, così come sono descritti dagli altri testimoni, unanimi. L'arto "riapparso" di Miguel Juan aveva un aspetto mortecino, livido come la morte, e in alcune parti appariva morado, viola; alcuni testimoni parlano di marbrures, che potrebbe tradursi come "macchie oscure".
«E incredibilmente preciso ed esatto!», commenta il professor Cùgola «Dalla nostra pratica sappiamo che, dopo un reimpianto, c'è differenza di aspetto tra arti inferiori e superiori, tra gambe e braccia. Queste ultime presentano un aspetto rosaceo, un colore più o meno naturale, mentre le gambe appaiono smorte, di un pallore cadaverico, con macchie violacee, soprattutto se il "riattaco" è stato tardivo, se sono passate diverse ore dall'incidente. E in questo caso, erano passati quasi due anni e mezzo dall'amputazione!».
Molti testimoni parlano di una gamba gangrenada, incancrenita. Il nostro specialista non è convinto da una simile diagnosi: «Tra la frattura della canilla, la tibia, a Castellòn de la Plana, e l'amputazione all'ospedale di Saragozza, passarono due mesi tra i più caldi dell'anno, agosto e settembre, con l'aggiunta del viaggio disumano da Valencia alla capitale dell'Aragona. Se davvero si fosse sviluppata la cancrena, il paziente sarebbe morto, per setticemia, molto prima dell'operazione. Penso, invece, che nella zona della frattura, che quasi certamente era esposta (e, cioè, con l'osso fratturato allo scoperto) si sia prodotta una osteomielite, un'infezione del midollo. Con la conseguente paralisi della circolazione del sangue, dovette originarsi un processo di mummificazione. Questo potrebbe spiegare, tra l'altro, come abbia potuto conservarsi il pezzo di gamba negli oltre due anni del seppellimento. Forse, anche così, si è attuato il piano divino non di "costruire" una gamba nuova, perché quella vecchia si era decomposta, ma di "recuperare" questa dal cimitero dell'ospedale. In essa, dovevano essersi conservate non solo le ossa, ma anche la carne, sebbene ridotta di grossezza per effetto della mummificazione».
Durante il processo, uno dei testimoni più importanti fu Miguel Barrachina, il vicino che, con la moglie Ursula, era stato dati Pellicer la notte del 29 marzo per la consueta veglia contadina. Stando nella casa attigua, sarà il primo estraneo alla famiglia ad accorrere, quando i suoi amici scopriranno quanto era avvenuto al figlio.
Nella testimonianza del Barrachina c'è l'abituale descrizione dell'aspetto del piede e del colore della gamba (mortecino, algo morado) che'abbiamo visto considerata dallo specialista moderno come segno di verità del reimpianto. Ma c'è anche una precisazione in più. Riportiamo ancora dagli atti dell'interrogatorio: «II deponente (Barrachina) dice che toccò la detta gamba destra e sentì che era dura molto più dell'altra e alquanto fredda e sentì dire dal detto Miguel Juan che il terzo giorno dopo che era successo il caso aveva sentito tornare tutto il calore naturale nella detta gamba e vide che poteva e può far girare il piede e le dita».
Come osserva il professore veronese, la sensazione provata dal teste Barrachina (rigidezza e freddezza della gamba) conferma che l'arto amputato e poi sepolto deve avere subito un processo di mummificazione; e conferma le dichiarazioni di altri deponenti, secondo i quali il giovane, subito dopo l'evento, «aveva la gamba come morta». Dice Cùgola: «I vasi sanguigni degli arti reimpiantati sono semiparalizzati, il flusso sanguigno è diminuito e la parte "riattaccata" appare più fredda e rigida. La sola singolarità, in questo caso, è la rapidità con cui la gamba riacquistò la sua piena funzionalità. Per quanto riguarda il colore e la consistenza dell'arto, i testi parlano di tre giorni. In una prospettiva di fede — potrebbe chiedersi il credente — questo periodo di tre giorni non potrebbe essere il segno della vita che ritorna, visto che Gesù risuscitò proprio il terzo giorno;».
Tra coloro che comparvero al processo e vi prestarono giuramento prima e dopo ogni risposta, c'erano i due chirurghi di Calanda: il giovane, Jusepe Nebot e quello che si era ormai ritirato, un anziano di 71 anni, Juan de Rivera. La testimonianza di quest'ultimo è di un professionista della medicina, che aggiunge un particolare che altri non danno: el tobillo enchado, la caviglia gonfia, che ha constatato palpando l'arto riapparso, il mattino dopo l'evento. Osserva Cùgola: «Anche qui, tutto esattamente secondo la nostra esperienza: il rallentamento del flusso sanguigno, con la difficoltà del ritorno venoso, provoca un ristagno del sangue e questo fa sì che si generi un rigonfiamento della caviglia».
Ma c'è un altro aspetto di questo caso straordinario. Tutti i testimoni affermano che Miguel Juan continuò a zoppicare anche qualche tempo dopo avere potuto appoggiare il piede per terra. Il fatto è che la gamba recuperata era più corta dell'altra (dicono unanimi) «di circa tre dita». Tra gli storici del Miracolo, alcuni hanno avanzato l'ipotesi che, nonostante avesse già compiuto vent'anni al momento dell'amputazione, il giovane non avesse ancora terminato del tutto il suo sviluppo corporale. Recuperando due anni e mezzo dopo la gamba, questa sarebbe risultata più corta, rispetto all'altra che aveva proseguito lo sviluppo naturale. Io stesso, nel libro, ho giudicato verosimile questa ipotesi.
Ma non è questa l'opinione del nostro
professore: «L'equivalente di tre dita è ciò che deve essere
stato perso di tessuto
osseo a causa della frattura più ciò che deve essere stato asportato dal chirurgo che, constatata una osteomielite, è
andato alla ricerca di tessuto non
lesionato». Tutti i testi, comunque, dicono che, nel giro di alcuni mesi, la gamba
destra recuperò la lunghezza di
quella sinistra. «Una crescita naturale», replica
Cùgola
«noi stessi, oggi, dopo un reimpianto, favoriamo questo allungamento dell'osso con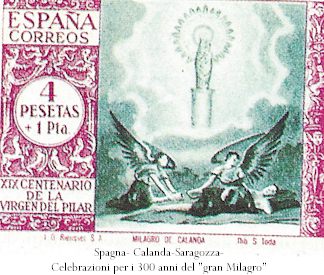 uno strumento che chiamiamo "fissatore
esterno" e che mantiene l'arto in tensione».
uno strumento che chiamiamo "fissatore
esterno" e che mantiene l'arto in tensione».
Ci fu un'ulteriore parte della gamba di Miguel Juan che risultava minore dell'altra e che col tempo riassunse la stessa dimensione: la pantorrilla, il polpaccio. Commenta il chirurgo: «Il polpaccio si era ristretto perché il muscolo si era mummificato. Con il ritorno del flusso sanguigno, del movimento, della vita, i nervi hanno riassunto la dimensione normale».
Insomma, dopo avere letto, con occhio professionale, le decine di dense pagine dell'interrogatorio dei testi al processo che si concluse con la sentenza dell'arcivescovo («... fu opera di Dio, per intercessione della Virgen del Pilar...»), il docente all'università di Verona non ha esitazioni: «Non posso far altro che ribadire la mia convinzione, e non come credente, ma come medico che si appoggia sulla sua esperienza clinica. Ciò che hanno visto e descritto quegli aragonesi del Seicento non è altro che il reimpianto di un arto inferiore destro. Tutto corrisponde a quanto constatiamo noi oggi. Non dimentichiamo mai che, all'epoca del Miracolo di Calanda, non si aveva neanche l'idea di che cosa fosse una simile operazione chirurgica. I primi tentativi — peraltro, falliti — risalgono agli anni Sessanta del Novecento, Per questo (oltre che per molte altre considerazioni che nel libro sono esposte) mi sembra evidente l'impossibilità di sospettare che quei testi abbiano potuto inventare una situazione per essi del tutto sconosciuta. Anzi, impensabile».